|
|
|
|
|
|
|
Archivio di grandi eventi
nazionali ed internazionali,
inchieste, reportages su
quotidiani e riviste celebri |
|
|
|
FINESTRE APERTE
SUL TERRITORIO |
|
 GENOVA
GENOVA |
|
Il
capoluogo della Liguria
ha il centro storico più grande
d'Europa. Nel 2004 è stata la
"Capitale Europea della Cultura"... |
|
 EUROFLORA
EUROFLORA |
|
In
primavera, ogni 5 anni,
alla Fiera di Genova va in scena
lo spettacolo dei fiori per eccellenza.
I giardini più belli del mondo... |
|
 VIA FRANCIGENA
VIA FRANCIGENA |
|
Col
Giubileo del 2000 è stata
definitivamente rivalutata
la via di Sigerico, che i pellegrini
percorrevano a piedi fino a Roma,
in segno di pentimento... |
|
 PARCO DEL MAGRA
PARCO DEL MAGRA |
|
A
Gennaio 2008 il Parco Naturale
Regionale del Magra è il territorio
eco-certificato più esteso d'Europa... |
|
 GOLFO DELLA SPEZIA
GOLFO DELLA SPEZIA |
|
Tra la punta
di Portovenere e il Capo Corvo si apre una delle più
profonde insenature di tutto il litorale occidentale
italiano, declamata nei versi di illustri poeti e nella
quale è incastonata La Spezia, città sede di porto
militare e mercantile, che oggi è anche punto di
attracco per le navi da crociera... |
|
 LE CINQUE TERRE
LE CINQUE TERRE |
|
Cinque
borghi marinari il cui destino è sempre stato
storicamente legato alla terra e all'agricoltura
piuttosto che alla pesca. Un paradiso naturale della
Liguria che nel 1997 è stato inserito dall'UNESCO tra i
Patrimoni Mondiali dell'Umanità... |
|
 LA VAL DI MAGRA
LA VAL DI MAGRA |
|
Nobili,
vescovi, mercanti e pellegrini
lungo l'asse della Via Francigena.
Culture differenti per storia e tradizioni,
nei secoli, si sono sovrapposte
e hanno permeato il territorio con
i segni del loro passaggio... |
|
 LA VAL DI VARA
LA VAL DI VARA |
|
La
"Valle dei borghi rotondi"
è anche conosciuta come
la "Valle del biologico" per le sue
produzioni agricole ottenute con
metodi antichi e naturali.
Varese Ligure nel 1999 è stato il
1° comune ecologico d'Europa... |
|
 LA LUNIGIANA
LA LUNIGIANA |
|
La
"Terra della Luna", in Italia,
ha la più alta concentrazione di
antichi castelli. Se ne contano
circa 160. Alcuni sono bellissimi e
perfettamente conservati... |
| |
|
|
|
|
|
Artisti a Forte dei Marmi
La città è
principalmente conosciuta per le sue rinomate spiagge e i suoi
famosi luoghi di ritrovo, teatro di vita mondana e polo di
attrazione per tanti vip. Ma, nel corso del tempo, Forte dei
Marmi è stata frequentata anche da molti artisti e personaggi di
cultura che qui hanno trovato ispirazione per i propri lavori... |
 |
|
|
|
|
Close Up |
|
Argomenti in primo piano,
fotografie, turismo, news e
storia del territorio |
|
|
|
Manuale del cicloturista |
 |
|
Per la realizzazione
delle immagini presentate in questo sito gli spostamenti sul
territorio della Lunigiana storica sono stati effettuati con una
bicicletta. In questa piccola guida sono state perciò condensate
varie esperienze logistiche e tecniche derivanti dall'utilizzo
turistico di questo mezzo di locomozione... |
|
Ciclabile del Canale Lunense |
 |
|
Inaugurato nel
maggio 1930, prende acqua dal fiume Magra, nei pressi di Isola
di Caprigliola, ed è la più importante opera idraulica ad uso
irriguo della Val di Magra.
Sulle sue sponde scorre oggi una pista ciclo-pedonale che
viene utilizzata anche come percorso alternativo
della Via Francigena... |
|
Itinerario cicloturistico sulle
colline della Val di Magra |
 |
|
E' un percorso circolare
che si sviluppa sulle colline ad est della Val di Magra. In partenza
si utilizza la pista ciclo-pedonale del Canale Lunense, fino
all'incrocio con Via Lago a Sarzana. Si prosegue poi su alcune
strade comunali a scarso traffico per toccare i borghi di
Falcinello, Ponzano Superiore e Caprigliola, i quali conservano
tuttora significative tracce del loro passato medievale... |
|
Itinerario cicloturistico
con transito a Bibola |
 |
|
E' un percorso
collinare e panoramico, quasi circolare, che si sviluppa lungo
diverse strade a scarso traffico. L'itinerario presenta due salite
importanti: la prima è quella che da Albiano Magra porta al bivio
per il Passo dei Solini, sull'Alta Via dei Monti Liguri; la seconda
è quella che collega Aulla a Bibola, storico borgo lungo il sentiero
di monte della Via Francigena... |
|
Itinerario cicloturistico
con transito a Ponzanello |
 |
|
E' un percorso
circolare e panoramico contrassegnato da due salite importanti.
La maggiore è quella che parte da Sarzana e si conclude sul
Monte Carbolo (collina di Canepari), dove viene raggiunta anche
la massima altitudine della giornata, pari a 657 metri di quota.
Al culmine della salita c'è il bivio per scendere a Ponzanello,
storico borgo che conserva intatte varie tracce del suo passato
medievale... |
|
Itinerario cicloturistico con
transito al Castello Aghinolfi |
 |
|
Si tratta di un itinerario
che porta verso Pietrasanta scorrendo sostanzialmente in pianura.
Fa eccezione l'ascesa verso il Castello Aghinolfi di Montignoso
al quale si arriva attraverso la Via dell'Arte che finisce nei
pressi di Strettoia. Tutta la salita è lunga circa 3 chilometri
e non presenta una pendenza proibitiva. La strada si chiama così
perché lungo il tragitto sono state collocate delle installazioni
dove sono in mostra, a stampa, le opere di vari artisti,
italiani e stranieri... |
|
Le vie di pellegrinaggio |
 |
|
I pellegrinaggi a
Gerusalemme iniziarono già dai primi secoli dopo la morte di
Cristo e, con la liberalizzazione del culto cristiano in epoca
costantiniana, i viaggi sporadici si trasformarono in un flusso
continuo di pellegrini in tutta la Terrasanta. La Via Francigena
non vide solo il passaggio di pellegrini, ma anche di viandanti
e mercanti... |
|
La Via Marchesana |
 |
|
E' una strada
storica che in epoca medievale veniva utilizzata dalla famiglia
Malaspina per raggiungere i propri possedimenti in alta Italia.
Il tracciato parte da Aulla, in Lunigiana, per raggiungere
la città di Pavia in Lombardia... |
|
Pievi romaniche |
 |
|
In
Lunigiana le pievi romaniche del periodo medievale costituiscono
esempi artistici molto rilevanti. Anticamente le pievi avevano
competenza esclusiva per la somministrazione dei sacramenti e
per la sepoltura, non essendo tale prerogativa riconosciuta a
cappelle, basiliche e monasteri... |
|
Castelli medievali |
 |
|
In Italia la Lunigiana ha la più alta concentrazione di antichi
castelli. Se ne contano circa 160. Alcuni sono bellissimi
e perfettamente conservati e/o ristrutturati, altri
un po' meno. Tutti hanno alle spalle storie interessanti... |
|
|
|
|
| |
|
Fotografie ©
GIOVANNI MENCARINI |
| |
|
Via Francigena
 Home Home |
 |
|
|
|
|
|
|
ORIGINI MILITARI |
|
La via
Francigena è una via formatasi nel corso dei
secoli con l'unione di diversi tratti di vie
romane e nata per scopi prevalentemente
militari. Con il tempo la strada divenne la
principale arteria di comunicazione fra
Roma, centro della cristianità, e l'Italia
padana, e quindi il centro Europa. |
|
|
|
|
Grande Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa
 Major Cultural Route of the Council of Europe
Major Cultural Route of the Council of Europe
 Grand
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe Grand
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe |
|
|
Non esistono
attestazioni dell'esistenza della Via Francigena
antecedenti all'inizio del secondo millennio. I primi
reperti che documentano con certezza la presenza di
questa via maestra sono proprio i diari che viandanti e
pellegrini tenevano per ricordare i loro viaggi, primo
fra tutti quello dell'Arcivescovo di Canterbury
Sigerico, scritto nel
994, quando si era recato nella Capitale per ricevere
l'investitura dal Papa. Sigerico impiegò circa due mesi
per percorrere i 1600 chilometri (suddivisi in 80 tappe)
che lo separavano dalla Santa Sede. |
|
 Da Canterbury a Roma: una via per il pentimento
Da Canterbury a Roma: una via per il pentimento |
Questa importante via di collegamento,
che da Canterbury portava a Roma, esisteva molto probabilmente
anche in epoca precedente. Le sue origini si collocano verosimilmente
nei secoli VI° e VII° per l'esigenza dei
Longobardi di collegare il regno di Pavia con i
territori del centro e i loro ducati del Sud Italia,
lontano dagli itinerari controllati dai Bizantini, loro
nemici irriducibili. Con i Franchi e i
Carolingi divenne
rotta di grande comunicazione per raggiungere Roma
collegando i luoghi sacri del mondo cristiano.
Un'arteria transitata da uomini e merci che,
congiungendo i principali centri abitati del tempo,
contribuì al rifiorire del commercio europeo.
La Via Francigena ha trovato ulteriore impulso nel momento in cui uomini di fede
hanno iniziato a percorrerla per ritrovare la perduta
«Patria Celeste».
In segno di pentimento, sulla Via Francigena si
camminava prevalentemente a piedi. Il pellegrino non viaggiava
isolato ma in gruppo e portava le insegne del pellegrinaggio.
E' noto infatti che in quell'epoca
l'Europa era attraversata da un reticolo di
strade punteggiate da santuari, cappelle, ospedali e
ricoveri presso i quali i viaggiatori potevano fare
tappa durante il loro lungo e difficile cammino.
Dall'XI secolo in poi la Via Francigena venne chiamata
anche Via Romea o "strata qui dicitur Romea" con
riferimento ad una delle principali mete dei pellegrini
medievali: Roma.
La bassa Val di Magra, attraversata da questa grande
arteria, costituiva nel Medioevo un importante snodo
stradale. Dalla Francigena si dipartivano infatti
numerose strade secondarie che raggiungevano la Val di
Vara e l'interno della costa, fino a Genova. Nel Golfo
della Spezia vi erano poi gli approdi, non secondari, di
Portovenere e Lerici, mentre sul Magra c'era il porto di
San Maurizio. |
 I tre distintivi dei pellegrini
I tre distintivi dei pellegrini |
|
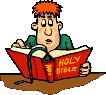
|
Le antiche strade dei pellegrini
convergevano verso tre poli di principale attrazione:
Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo;
Santiago de Compostela dove riposava in
pace l'Apostolo San Giacomo e
Gerusalemme in Terra Santa. Coloro
che si recavano a Roma portavano come distintivo
la chiave (San Pietro);
la conchiglia
era il simbolo di chi era diretto verso
Santiago de Cospostela |
|
|
e la
croce contraddistingueva i pellegrini in viaggio verso i
luoghi della passione di Cristo.
Nel Medioevo, a partire dal 1095,
le Crociate diedero un grande
impulso a questa arteria utilizzata per
recarsi al Santo Sepolcro liberato. |
 Per maggiori informazioni vedi il link "Le strade dei pellegrini"
Per maggiori informazioni vedi il link "Le strade dei pellegrini" |
 Il primo Giubileo di Papa Bonifacio VIII
Il primo Giubileo di Papa Bonifacio VIII |
|
Nel 1300
il Giubileo indetto da
Papa Bonifacio VIII
ottenne il doppio risultato di riportare Roma al
centro della cristianità, sottratta nei secoli
precedenti da Gerusalemme e di generare una
grande circolazione di denari e commerci che
diedero linfa vitale ad una città che languiva
dopo i fasti dell'Impero Romano. Per questo
motivo la Via Francigena divenne sempre di più
itinerario |
|
|
indispensabile per il
territorio e polo d'incontro di etnie e culture
diverse. |
|
 Tracciato principale nel territorio italiano
Tracciato principale nel territorio italiano |
La Via Francigena o "Romea"
oltrepassava le Alpi in Valle
d'Aosta e scendeva dal Piemonte e dalla
Lombardia nella Pianura Padana. Dall'Emilia il
tragitto puntava verso la costa ligure-toscana,
per valicare l'Appennino nei pressi di Berceto
ed arrivare nella Lunigiana Storica attraverso
il Monte Bardone, oggi Passo della Cisa.
La Via Francigena, in Toscana, faceva tappa a
Pontremoli e poi ad
Aulla, seguendo un percorso
senza particolari dislivelli (quota massima 250
metri) tra borghi fortificati e castelli dei feudi
Malaspina.
Dopo l'elegante Pieve di Sorano entrava nel
borgo di Filattiera, con le imponenti case
torre. La pieve romanica di
S.Stefano
di Sorano fu edificata probabilmente sulle
rovine di un edificio di culto pagano
preesistente, come dimostra il ritrovamento di
statue stele al di sotto e all'interno
dell'edificio. Non si hanno notizie certe sulla
sua edificazione; le prime notizie documentate
risalgono ad una bolla papale del 1148.
La pieve fu per secoli un centro religioso molto potente.
La sua importanza era legata alla posizione
strategica: qui convergevano infatti le
principali strade di |
 La leggenda di M. Filippo Caldani, il predone della
Via Francigena
La leggenda di M. Filippo Caldani, il predone della
Via Francigena |
|
Matteo Filippo
Caldani era un nobile veronese che, tra la fine del
Cinquecento e l'inizio del Seicento, aveva la sua dimora
presso il Castellazzo di Aiola, alle pendici del monte San
Giorgio. Dal suo nido d'aquila - si narra - scendeva
soltanto in compagnia dei suoi «bravi» per andare a compiere
scorrerie lungo la Via Francigena.
Un giorno di maggio, dopo avere compiuto alcuni furti nei
pressi di Pontevecchio nella valle del Bardine, stava
facendo ritorno al suo inespugnabile maniero quando, nei
pressi della Chiesina di Viano, scoppiò all'improvviso un
furioso temporale.
I predoni, colti di sorpresa, accelerarono il cammino per
trovare riparo nell'edificio sacro. Giunti però davanti alla
chiesa sentono levarsi al cielo il canto soave di alcune
fanciulle che stanno pregando affinché il temporale cessi.
Quel canto è come una folgore nel cuore di Matteo che
capisce di avere condotto un'esistenza di delitti e
scelleratezze. Colto dalla vergogna fugge immediatamente
verso il fondovalle.
Giunto al ponte di Santa Lucia, nei pressi di
Monzone,
mentre tutt'attorno si abbattono i fulmini decide di
cambiare vita: scioglie la sua banda, getta nel fiume la
chiave dello scrigno contenente la refurtiva e si ritira sul
Monte San Giorgio dove costruisce un eremo per dedicarsi ad
una vita di penitenza e carità.
Un giorno - continua la leggenda - gli viene portata in dono
una grossa trota di oltre 6 libbre (circa tre chili), pescata nel
torrente Lucido.
Nel prepararla per la cottura,
tra lo stupore e la felicità, rinviene nel ventre del pesce
la chiave che aveva gettato nel fiume al tempo in cui era un ladrone.
Un segno che Dio l'aveva perdonato! |
|
|
comunicazione che connettevano
(attraverso i valichi dell'Appennino) la Val di Magra con la Valle del
Po. Nel corso del tempo il luogo si spopolò in
favore dell'attuale borgo di Filattiera.
L'insalubrità del fiume Magra e la scarsa
sicurezza del fondovalle ne causarono un lento
declino, fino al completo abbandono avvenuto nel
XVIII secolo. La pieve ha subito un importante
restauro terminato per il Giubileo del 2000 ed
oggi è aperta al culto e visitabile.
Oltrepassata Filattiera, la VF proseguiva
lungo la valle del torrente Monia giungendo
a Filetto e quindi a Villafranca. Attraversato
il torrente Bagnone i pellegrini salivano a
Virgoletta, procedendo poi per Terrarossa, dominata dal
Castello Malaspina, prima di
giungere al punto tappa all'Abbazia
di San Caprasio di Aulla.
Aulla fu annotata dall'Arcivescovo di
Canterbury Sigerico come XXX tappa. La
cittadina, sorta su un'importante strada romana
che da Luni conduceva a Parma, era difesa da
fortificazioni che divennero nel XV secolo la
Fortezza della Brunella, così detta per il
colore della roccia su cui si erge, e oggi sede
del Museo di storia naturale della Lunigiana. Le
sue mura racchiusero l'ospitale dei pellegrini e
l'abbazia fondata nell'884 e intitolata a San
Caprasio, del quale custodisce le
spoglie. Nel circondario si possono ammirare i
borghi di Bigliolo (con i resti del castello) e
Pallerone. Poco oltre Aulla, lungo il sentiero
di monte, si incontra il castrum di
Bibola.
Chi invece percorre il sentiero di valle, lungo
le sponde del Magra, arriva a Caprigliola,
medievale residenza estiva del vescovo conte di Luni.
Siamo ormai in Val di Magra dove la VF
scendeva al mare verso l'antico porto
di Luni, attraversando un lembo dell'attuale
Liguria e lasciandosi dietro la città di
Sarzana. |
|
IL BORGO E IL CASTELLO DI AVENZA |
|
|
erano
un importante luogo di tappa della
Via Francigena in periodo medievale e,
forse, già in epoca romana, della Via Emilia Scauri.
Il borgo fu terra murata nel XII secolo.
Nel XIV secolo venne dotata di un castello e,
successivamente, nel XV secolo,
potenziata con la costruzione di una
fortezza di cui oggi resta uno dei tre
torrioni circolari. La vicinanza col
mare favorì lo sviluppo delle attività
portuali, protette dalla fortezza e dal
perimetro murato del borgo. Porto
Chaco, il |
|
Porto di Avenza, era in posizione
centrale nel sistema di approdi
litoranei e, a partire dal XIII secolo,
con la decadenza del porto fluviale di
San Maurizio, assunse il ruolo di
principale approdo dell'area lunense.
Tra il XIV e XV secolo raggiunse il
momento di massima attività di scambi in
tutto il Mediterraneo. |
|
Nella seconda metà del secolo XII il tratto
della strada Romea che passava per Luni venne
definitivamente abbandonato a causa del
progressivo impaludamento della fascia costiera
e Sarzana subentrò come tappa più sicura
rispetto alla città romana, ormai in fase di
inarrestabile decadenza.
Sarzana invece viveva una stagione di
intenso incremento demografico e di crescita urbanistica
che, verso la fine del XII secolo, portarono alla
costruzione di un borgo popolato, fornito di due
chiese e di un luogo di accoglienza, l'ospedale di
San Bartolomeo. La
Cattedrale di Santa Maria e San Basilio venne ricostruita ed ampliata
sul luogo dell'antica Pieve di San Basilio,
tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo.
Anche Sant'Andrea venne ristrutturata,
con ampliamento del corpo di fabbrica e
trasformazione della primitiva chiesa romanica,
a tre navate, in un'unica ed ampia aula
monoabsidale, con copertura lignea a capriate e
cappelle parietali. L'insediamento di Sarzana si
formò sotto la protezione del "castrum Sarzanae",
proprietà del vescovo di Luni almeno dal 963.
A cavallo tra Liguria e Toscana, volgendo lo
sguardo sulle colline prospicienti la costa, è
possibile ammirare
Fosdinovo, citato per la prima
volta nell'XI secolo. Le origini di
Fosdinovo (dal latino Fauce Nova, nuovo
passaggio) furono conseguenti ad un nuovo
tracciato tra il litorale e le valli più interne
della Lunigiana. Il borgo deve la sua importanza
al castello Malaspina, tra i meglio conservati
di tutta la Lunigiana. L'imponente mole della
fortificazione (costruita in posizione tale da
permettergli il controllo sulle strade del tempo
e sulle zone costiere) racchiude oggi una dimora
di impronta rinascimentale ancora completamente
arredata e visitabile. Le prime notizie si hanno
nel 1124, quando il castello era un sub feudo dei
vescovi conti di Luni, prima che la prepotente
ascesa dei marchesi Malaspina (alla fine del
XIII secolo) facesse tramontare il potere
vescovile su queste terre.
Lasciata la Liguria, la VF continuava lungo la via romana
Emilia Scauri per giungere a Massa e
Pietrasanta, patria della scultura e del
marmo delle
Alpi Apuane che riveste le chiese, oggi
popolata da artisti che provengono da tutto il mondo.
Seguendo le pendici delle Apuane conduceva al fiume Serchio
e alla potente Lucca, rifugio sicuro e tappa di
devozione grazie al crocifisso del
Volto Santo
(vedi
strada omonima)
custodito nella cattedrale di San Martino.
Da notare che Lucca, per il grande numero di
edifici di culto (risalenti a varie |
|
epoche) costruiti all'interno del centro storico,
è tradizionalmente conosciuta come la «città delle
cento chiese». Ai nostri giorni, molti edifici
religiosi risultano sconsacrati, ma permangono
ugualmente luoghi di grande interesse culturale
e turistico. Oltre al Duomo, meritano di essere
visitate anche la Chiesa di San Michele (foto a
lato), la Basilica di San Frediano e la Chiesa di San Paolino.
Dopo Lucca, la Via Francigena proseguiva verso
Altopascio, sede dei Frati Ospitalieri,
e poi attraversava l'Arno a Fucecchio, prima di giungere a San Miniato,
roccaforte dei Sassoni in Toscana. |
|
|
Percorrendo la valle del fiume Elsa, il
pellegrino arrivava a Gambassi e già vedeva il
profilo delle torri di San Gimignano. Da qui,
percorrendo territori contesi da Firenze e
Siena, raggiungeva le mura che ancora
circondano Monteriggioni e poi la ricca
Siena, che offriva ai pellegrini le cure
dell'ospitale di
Santa Maria della Scala.
Traversando il «deserto d'Accona»
entrava nel borgo di Buonconvento, ancora oggi
perfettamente conservato. Penetrava poi nella Val d'Orcia,
passando per i borghi arroccati di
San Quirico e Castiglione, per giungere a
Radicofani (vedi link
VF nella Valle del Paglia),
ultima tappa Toscana prima del tratto laziale (vedi link
Cesano di Roma)
che consentiva di raggiungere la città eterna.
In Toscana, attraverso la Via Francigena
si diffusero idee, innovazioni, modelli
culturali e influenze artistiche che,
entrando in relazione con le
realtà delle zone attraversate,
assunsero specifiche connotazioni
locali. Soprattutto negli edifici
religiosi si ritrovano elementi
costruttivi e simbolici tipici del
pellegrinaggio, come i
portali gemini
o il labirinto,
rappresentazione del cammino verso Dio. e caratteri
provenienti dall'architettura romanica
d'Oltralpe mediata, nelle forme e nei
modelli, dalle espressioni locali come
quella pisana, lucchese o volterrana.
La storia della VF rimanda al
Medioevo in Toscana non solo come
percorso della memoria ma, come chiave
interpretativa attraverso la quale
rileggere il territorio, la sua
organizzazione, le sue peculiarità ed
identità. Il ruolo della Via Francigena
è stato quello di esaltare le
specificità locali in un quadro europeo;
alcune aree, come quelle di confine, per
la lunga permanenza del feudalesimo
furono caratterizzate dalla presenza di
numerose strutture fortificate, di cui
rimangono preziose testimonianze, altre
si distinsero per lo sviluppo degli
scambi economici, delle attività
finanziarie e manifatturiere svolgendo
un ruolo di assoluto rilievo nei mercati
tra Oriente ed Occidente, tra
Alessandria d'Egitto e le fiere della
Champagne.
La nascita della VF valorizzò alcune
città di antica fondazione come
Lucca e Siena e determinò la fioritura
di altri insediamenti come San Miniato,
San Gimignano, Colle Val d'Elsa o
Pescia, piccole realtà urbane
protagoniste, nel Medioevo,
dell'economia europea. |
|
|
 Edifici di culto e percorsi religiosi nella Lunigiana
medievale
Edifici di culto e percorsi religiosi nella Lunigiana
medievale |
L'opera dei missionari, dei monaci, dei chierici e quella dei
vescovi ha lasciato importanti e diffusi segni di sé
nella storia e nel paesaggio della Lunigiana medievale,
definita dai confini della Diocesi di Luni,
città che fin dall'epoca romana rappresentò il centro
principale di un territorio con funzione strategica di
collegamento tra Roma e la Padania, tra vie di terra e
vie di mare e che fu alla base della sua espansione. La
Lunigiana è storicamente identificabile con il
territorio posto sotto la giurisdizione di Luni
corrispondente al municipium romano e
successivamente all Diocesi istituita tra V e VI secolo.
E' lecito supporre che, nell'alto Medioevo, i
pellegrini si fermassero anche a Luni e trovassero
conforto spirituale presso la basilica che vi sorgeva.
La frequenza lungo la via di fedeli pellegrini è
testimoniata, fino al secolo VIII, da una lapide tombale
posta entro la
Chiesa di San Giorgio a Filattiera. Il
decumano massimo costituiva il tratto cittadino della
Via Aurelia o almeno della continuazione di questa
importante arteria romana che consentiva il collegamento
di Luni con Roma, Genova e Parma. Le grandi vie
medievali della Lunigiana ricalcavano, più o meno
direttamente, le strade consolari romane. La Via
Francigena, per il tratto cha da Luni arrivava al Passo
della Cisa, ripercorreva probabilmente l'antica arteria
romana anche se, di questa coincidenza, non vi sono però
testimonianze certe.
Nel IX e XII secolo Luni, antica colonna romana e porto
fiorente almeno fino a tutto il III secolo, doveva
conservare pochi residui del suo antico splendore. Le
incursioni saracene, l'impaludamento della pianura e
l'imperversare della malaria ne causarono la decadenza e
lo stesso percorso della Romea fu spostato più a
settentrione.
Le origini delle pievi, delle abbazie e dei monasteri
erano spesso connesse alla viabilità. Le abbazie
erano strategicamente collocate a controllo dei percorsi
di valico, come nel caso di Linari e di Montelungo, o in
punti nodali, come ad Aulla.
Nella Lunigiana orientale le pievi segnavano un ramo
della Via Francigena che, partendo da Filattiera, si
dirigeva al Passo di Tea (dove era lo spedale di San
Nicolao) per poi proseguire verso Lucca attraverso la
Garfagnana. Questo era un ramo alternativo al percorso
costiero della Via Francigena documentato nel 990 da
Sigerico, Arcivescovo di Canterbury.
La connessione tra viabilità e sistema religioso,
caratterizzante tutte le aree interessate dalla Via
Francigena, in Lunigiana assunse caratteristiche
peculiari dovute agli interessi su comprensori di
importanti abbazie del nord della Penisola e dei ceti
dirigenti, che si accentuarono dopo la divisione, nel
1204, della Diocesi di Luni in quella di Sarzana e
Brugnato, che sancì la decadenza dei Vescovi di Luni. |
 Il crocevia nei pressi di Santo Stefano di Magra
Il crocevia nei pressi di Santo Stefano di Magra |
|
|
Nella Provincia della
Spezia dalla Via Francigena si
dipartivano numerose strade secondarie che
collegavano tra loro gli insediamenti della
costa e dell'entroterra.
Una di queste la metteva in comunicazione
con la "Via Litoranea", di origini
forse preistoriche, che univa
Portovenere a Sestri Levante sempre |
|
|
mantenendosi sullo
spartiacque costiero ad un'altezza media di 400-500
metri. Questa nasceva a Portovenere, passava sul crinale delle
Cinque Terre,
proseguiva per i monti Bardellone, Guaitarola,
Sant'Agata e San Nicolao, presso il
Passo del Bracco per
poi scendere lungo la costa di Sestri Levante. |
Vicino a Santo Stefano di Magra, un tempo sede di
mercato, si trovava un importante snodo viario dove
confluivano le direttrici del percorso di valle
(vedi link Apertura VF di valle)
e quello di monte che collegava Aulla con Sarzana
attraverso il Castello della Brina.
Sotto il poggio di Caprigliola, i «viatores» diretti a Santiago de Compostela
guadavano il fiume Magra
per percorrere il tragitto che, attraverso la Val di Vara,
entrava nel territorio di
Genova.
|
|
|
Presso Bocca di Magra esisteva il
Porto di San Maurizio
dal quale partivano i pellegrini diretti via mare verso
la Penisola Iberica e la Galizia. |
|
 La "Via di Sigerico" dichiarata "Itinerario Culturale
Europeo"
La "Via di Sigerico" dichiarata "Itinerario Culturale
Europeo" |
|
|
La "Via di Sigerico",
fatto salvo l'aspetto religioso iniziale, è stata
comunque una grande strada di comunicazione, che ha
visto il cammino di eserciti, mercanti, maestranze e
uomini di fede, contribuendo in maniera decisiva
allo sviluppo economico e sociale dei borghi che
incontrava lungo il suo percorso.
Il Consiglio d'Europa,
accogliendo pertanto le richieste di tutte queste
realtà locali, ha dichiarato la Via Francigena
"Itinerario Culturale Europeo". Il
Giubileo del 2000 ha contribuito enormemente a
riscoprire e rivalutare il percorso in epoca
moderna. Ad Ottobre 2007 sono stati posizionati a
Monteriggioni, in Toscana, i primi cartelli
indicatori del tratto nazionale (vedi link "Lucca e
il Volto Santo) ...
Dall'inizio del nuovo millennio, numerose sono state le |
|
Dal
volume "San Pellegrino tra mito e storia - I luoghi
di culto in Europa" a cura di Adelaide
Trezzini (AIVF) - Gangemi Editore 2009 |
iniziative a carattere turistico-culturale volte a riqualificare
socialmente ed economicamente tutti i territori
attraversati da questo antico tracciato.
L'intendimento è che la Via Francigena non rimanga
solo un percorso per nuovi pellegrini o appassionati
dei cammini pedestri, ma diventi un'idea di viaggio
per molti turisti e visitatori.
Un "modus vivendi" che sappia coniugare l'esigenza di
muoversi lentamente all'aria aperta, attraversando paesaggi ricchi
di storia e bellezze naturali, |
|
ma con la possibilità di fruire di
confortevoli strutture ricettive e presenziare ad eventi
che hanno come scopo primario quello di mettere
in contatto le varie etnie legate alla
strada, per proficui scambi culturali.
Nella sezione «Eventi, iniziative, studi»
di questo sito c'è un piccolo panorama di
quanto viene allestito nel tratto che
attraversa le regioni Liguria, Toscana e Lazio.
A dicembre 2009, nel Lazio, ha iniziato il
percorso di approvazione un progetto per la
«Variante dei Laghi».
Una modifica urbanistica che prevede il passaggio della
Via Francigena nel Borgo di Cesano,
Santa Maria Galeria, Isola Farnese
e La Storta.
La proposta redatta dalla
Commissione Ambiente e
Grandi Parchi del Municipio Roma XX,
in |
|
|
collaborazione con l'Associazione
Internazionale Via Francigena e il
coinvolgimento della
Regione Lazio, rappresenta
un evento fondamentale per lo
sviluppo storico, culturale e religioso per
il quadrante di Roma Nord. Infatti il tratto
individuato risulterebbe essere
la porta settentrionale attraverso la
quale i pellegrini transitano in direzione
San Pietro. Con questo atto, la
Commissione vuole anche rendere merito a
tutte le persone, le associazioni e gli enti
che in questi anni si sono prodigati e
battuti nel salvaguardare una memoria
storica e una tradizione del nostro
passato. |
|
|
 Fonti:
Fonti: |
| Speciale
Turismo La Spezia - Il Secolo XIX; |
| Association
Internationale Via Francigena; |
| Segnaletica
turistica dei Percorsi Religiosi. |
|
|
|
|
- Immagini dalla "Rievocazione di un antico mercato
sulla Via Francigena" a SANTO STEFANO di MAGRA |
|
|