|
|
|
|
|
|
|
Archivio di grandi eventi
nazionali ed internazionali,
inchieste, reportages su
quotidiani e riviste celebri |
|
|
|
FINESTRE APERTE
SUL TERRITORIO |
|
 GENOVA
GENOVA |
|
Il
capoluogo della Liguria
ha il centro storico più grande
d'Europa. Nel 2004 è stata la
"Capitale Europea della Cultura"... |
|
 EUROFLORA
EUROFLORA |
|
In
primavera, ogni 5 anni,
alla Fiera di Genova va in scena
lo spettacolo dei fiori per eccellenza.
I giardini più belli del mondo... |
|
 VIA FRANCIGENA
VIA FRANCIGENA |
|
Col
Giubileo del 2000 è stata
definitivamente rivalutata
la via di Sigerico, che i pellegrini
percorrevano a piedi fino a Roma,
in segno di pentimento... |
|
 PARCO DEL MAGRA
PARCO DEL MAGRA |
|
A
Gennaio 2008 il Parco Naturale
Regionale del Magra è il territorio
eco-certificato più esteso d'Europa... |
|
 GOLFO DELLA SPEZIA
GOLFO DELLA SPEZIA |
|
Tra la punta
di Portovenere e il Capo Corvo si apre una delle più
profonde insenature di tutto il litorale occidentale
italiano, declamata nei versi di illustri poeti e nella
quale è incastonata La Spezia, città sede di porto
militare e mercantile, che oggi è anche punto di
attracco per le navi da crociera... |
|
 LE CINQUE TERRE
LE CINQUE TERRE |
|
Cinque
borghi marinari il cui destino è sempre stato
storicamente legato alla terra e all'agricoltura
piuttosto che alla pesca. Un paradiso naturale della
Liguria che nel 1997 è stato inserito dall'UNESCO tra i
Patrimoni Mondiali dell'Umanità... |
|
 LA VAL DI MAGRA
LA VAL DI MAGRA |
|
Nobili,
vescovi, mercanti e pellegrini
lungo l'asse della Via Francigena.
Culture differenti per storia e tradizioni,
nei secoli, si sono sovrapposte
e hanno permeato il territorio con
i segni del loro passaggio... |
|
 LA VAL DI VARA
LA VAL DI VARA |
|
La
"Valle dei borghi rotondi"
è anche conosciuta come
la "Valle del biologico" per le sue
produzioni agricole ottenute con
metodi antichi e naturali.
Varese Ligure nel 1999 è stato il
1° comune ecologico d'Europa... |
|
 LA LUNIGIANA
LA LUNIGIANA |
|
La
"Terra della Luna", in Italia,
ha la più alta concentrazione di
antichi castelli. Se ne contano
circa 160. Alcuni sono bellissimi e perfettamente
conservati... |
|
Le Alpi Apuane |
|
Monumento geologico
unico al mondo |
|
La natura delle Alpi Apuane
Le Alpi Apuane sono il territorio più
singolare e prezioso delle province di Massa Carrara e
Lucca. Rappresentano un biglietto da visita di
grande prestigio in campo naturalistico,
anche a livello internazionale. Il loro nome
deriva dall'antico popolo che le abitò in
epoca preromanica: i Liguri Apuani... |
 |
|
Alpi Apuane (2)
Il Vallone della Canalonga
La lizzatura del Monolite
Cava dei Fantiscritti
Lizzatura storica ai Ponti di Vara |
 |
|
Alpi Apuane (3) |

|
|
Alpi Apuane (4)
La ripida «Via Vandelli»
La Ferrovia Marmifera
Quando i Cavatori di Carrara
salvarono il sito egiziano
di Abu Simbel
Bandiera USA da record
realizzata in marmo |
 |
|
Alpi Apuane (5)
La strada panoramica che da Massa porta al Passo del Vestito
L'acqua delle Terme di San Carlo
L'Orto Botanico di Pian della Fioba
Minerali rari e/o sconosciuti
La Fiera Marmi-Macchine
di Carrara |
 |
|
Alpi Apuane (6)
Michelangelo e altri illustri
scultori a Carrara
L'Accademia di Belle Arti
La Biennale Internazionale
di Scultura |
 |
|
Alpi Apuane (7)
Antiche tecniche per l'estrazione
e il trasporto dei marmi
I buoi dalle lunghe corna,
signori delle strade del marmo
I bastimenti a vela per il trasporto
dei blocchi di marmo via mare |
 |
|
Lago di Gramolazzo
E' un bacino artificiale della Garfagnana costruito negli anni
'50 del XX secolo. Sulle sue dolci sponde sono state ricavate
alcune spiagge atte alla balneazione. Per questo motivo e per
altre strutture ricettive che esistono in zona è diventato una
meta molto ambita dai turisti... |
 |
|
|
Close Up |
|
Argomenti in primo piano,
fotografie, turismo, news,
eventi e storia del territorio |
|
|
|
Itinerario cicloturistico sui
monti del versante di Vinca |
 |
|
Prima di inerpicarsi verso
le montagne si attraversa parte della Valle del Lucido. Il punto
più alto si raggiunge a Vinca, amena località posta a poco più di
800 metri sul livello del mare e sovrastata dai monti Sagro e Pizzo
d'Uccello. Il percorso non presenta particolari difficoltà, eccetto
gli ultimi 4 chilometri di salita nel Vallone della Canalonga,
dove le pendenze non scendono sotto il 10%... |
|
Itinerario cicloturistico
verso Carrara e Colonnata |
 |
|
Si tratta di un
percorso mare-monti che presenta pochi punti in comune tra
andata e ritorno. Dal litorale toscano si raggiungono le
Alpi Apuane del versante di Colonnata, borgo rinomato in tutto
il mondo per il suo prelibato lardo, dove si tocca la massima
altitudine della giornata. E' un viaggio storico-culturale
che consente di apprezzare tante particolarità e curiosità
relative al mondo del marmo e dei cavatori... |
|
Itinerario cicloturistico nelle
valli dell'Aulella e del Lucido |
 |
|
Il viaggio si svolge
lungo la dorsale delle colline che dividono le valli dei torrenti
Aulella e Lucido. Il punto più lontano è rappresentato dalla
località Equi Terme dove sorge un rinomato stabilimento termale.
Lungo il percorso sono presenti vari saliscendi, dove l'altitudine
massima non è superiore ai 400 metri. Il rientro avviene attraverso
la salita che collega Monzone a Casciana, corta ma impegnativa... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fotografie ©
GIOVANNI MENCARINI |
| |
|
Le Alpi Apuane  (3) (3) |
Monumento geologico
unico al mondo |
|
|
|
|
|
|
|
 Ai tempi dei Romani era chiamato il Marmo di Luni
Ai tempi dei Romani era chiamato il Marmo di Luni |
Per secoli, durante l'Impero
Romano, il marmo delle Apuane fu conosciuto come
il "marmo di Luni".
La colonia romana di Luni, fondata nel II
secolo a.C. durante la guerra contro i Liguri-Apuani,
prosperò grazie alle sue fiorenti attività
economiche.
Fra queste spicca quella marmifera che determinò la
formazione di insediamenti sparsi nel carrarese.
Dopo il 155 a.C., alla conclusione delle guerre
contro i Liguri, la colonia ebbe un florido sviluppo
dovuto principalmente alle attività agricole
praticate nel territorio circostante, suddiviso in
lotti regolari detti «centurie», e a quelle
commerciali favorite dal suo porto, dal fiume Magra
e dalla importante rete viaria che attraversava il
territorio.
A partire dal I secolo a.C. si registrò un notevole
miglioramento nella vita socio-economica dei suoi
abitanti in virtù dello sfruttamento intensivo
dei ricchi giacimenti marmiferi delle Alpi Apuane.
Iniziò proprio in questo periodo l'occupazione
stabile della valle del Carrione, da dove si poteva
più facilmente gestire l'escavazione del marmo.
Sino ad allora la Grecia, l'Asia Minore e l'Africa
erano stati i principali luoghi di provenienza del
prezioso materiale. Da quel momento in poi anche
Luni, con i suoi giacimenti marmiferi, entrò a far
parte dell'ampio piano di approvvigionamento dei
marmi che si estendeva a tutto il bacino del
Mediterraneo.
Dagli scritti di Plinio il Vecchio (Naturalis
Historia, XXXVI,7) si apprende che il primo utilizzo
a Roma del marmo lunense si ebbe nel 48 a.C. quando
Mamurra, prefetto di Cesare in Gallia, lo impiegò
per la sua casa e lo stesso Cesare lo utilizzò per
la costruzione del Foro.
Tra l'Ottocento e il Novecento la rimozione di
antichi ravaneti ha portato alla scoperta e al
recupero di un notevole numero di reperti
archeologici di epoca romana, collocandoli tra il
secondo secolo avanti Cristo ed il terzo dopo
Cristo. In numerose cave antiche, abbandonate dai
Romani tra il terzo ed il sesto secolo dopo Cristo,
furono rinvenute monete, oggetti d'uso domestico,
statuette, rilievi, epigrafi civili e sepolcrali
incise su lastre di marmo.
Alcuni di questi reperti sono andati perduti, altri
vengono conservatia Carrara nel Museo del Marmo o
all'Accademia di Belle Arti. |
 Splendore e decadenza della città romana di Luni
Splendore e decadenza della città romana di Luni |
I marmi apuani vennero utilizzati per il restauro
e l'ampliamento dei più importanti edifici
pubblici di Luni (il Capitolium,
il Foro e il Grande Tempio) e
per la costruzione di edifici privati come la
Casa degli Affreschi.
A quest'epoca si daterebbe anche
l'Anfiteatro.
La quantità e varietà dei marmi apuani, la capacità
organizzativa del lavoro, la localizzazione delle
cave, non troppo distanti dalla costa, e la sua
vicinanza a Roma determinarono la fortuna di Luni e
del territorio direttamente coinvolto nelle attività
di estrazione e trasporto del marmo sotto il
controllo dell'autorità dell'Imperatore Augusto. |
|
In età augustea la
colonia ebbe una generale riorganizzazione ed un'ulteriore
monumentalizzazione consistente in alcune modifiche
del Capitolium (bacino-fontana a U) e nella
costruzione della Basilica
civile, del Teatro e della Casa dei
Mosaici.
Nello stesso tempo l'escavazione dei marmi
gestita su scala industriale fece di Luni uno dei
centri marmiferi più importanti del Mediterraneo.
I candidi blocchi vinsero la concorrenza del marmo
greco di Paro e furono utilizzati per i templi, i
monumenti, le statue.
Il porto di Luni, vicino alla foce del Magra, era
ben attrezzato per imbarcare il marmo estratto e
trasportato sul litorale dalle limitrofe montagne. |
 |
|
Busto in memoria di Renato Salvatori |
|
|
Il Portus Lunae
esisteva già prima della colonizzazione
romana (come ricordano le fonti letterarie
antiche) anche se non è mai
stato identificato con precisione. La ricerca
archeologica ha dimostrato che fu frequentato dagli
Etruschi, dai Liguri, ed in seguito utilizzato dai
Romani come base per le spedizioni militari contro i
Liguri-Apuani.
Il porto di Luni godeva di un'importante centralità
rispetto alle rotte commerciali marittime che
raggiungevano la province Romane del bacino
occidentale del Mediterraneo. Il suo interramento,
dovuto principalmente alle piene
del Magra, fu una della cause primarie della
decadenza cittadina, la cui ricchezza perdurò fino
al III secolo d.C., come si può leggere in una nota
epigrafe del 255 d.C. che recita: "Splendida
Civitas Nostra Lunensis". |
 Eventi artistici a Carrara e dintorni
Eventi artistici a Carrara e dintorni |
|
|
 White Carrara 2025 - Design Here and Now
White Carrara 2025 - Design Here and Now |
|
Design Here and Now
è il tema di White Carrara 2025 per celebrare il design del
marmo in città con mostre, installazioni, talk, eventi e visite guidate
nel centro storico di Carrara che, per l'occasione, si trasforma in
un dinamico spazio espositivo e laboratorio creativo a cielo
aperto... |
|
|
|
|
 White Carrara 2024 - Design is Back
White Carrara 2024 - Design is Back |
|
L'evento è una
galleria all'aria aperta che vede, da un lato, la presentazione
di alcuni progetti realizzati nel tempo nei laboratori cittadini
e, dall'altro, si concentra sulle nuove proposte di designer
contemporanei... |
|
|
|
|
 White Carrara 023 Still Liv(f)e
White Carrara 023 Still Liv(f)e |
|
Nel 2023 gli
organizzatori hanno giocato sul tema della trasformazione dal blocco non
lavorato (Still Life) alle varie forme della scultura contemporanea (Still
Alive). In esposizione c'erano i lavori di 8 scultori riconosciuti sulla
scena italiana ed internazionale... |
|
|
|
|
 White Carrara Downtown 2021
White Carrara Downtown 2021 |
|
L'evento è stato
dedicato alle eccellenze artistiche, culturali e culinarie della
città toscana. Verso la fine di luglio, nel centro storico si
è aperto un percorso museale urbano, caratterizzato da mostre,
installazioni, laboratori aperti al pubblico, eventi musicali, teatro... |
|
|
|
|
 Simposio di scultura in Piazza Duomo
Simposio di scultura in Piazza Duomo |
|
In Piazza Duomo a
Carrara, a fianco della casa ove soggiornò varie volte il grande
Michelangelo, si svolge ogni anno un simposio di scultura a mano
al quale partecipano una diecina di artisti provenienti da ogni
parte del mondo... |
|
|
|
|
 Simposio di scultura ad Avenza
Simposio di scultura ad Avenza |
|
In Piazza Finelli ad
Avenza si svolge un simposio di scultura che vede
protagonisti alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di
Carrara. E' la stessa scuola che lo organizza per promozionare
il tracciato della Via Francigena tra Carrara e Massa... |
|
|
|
|
 TORANO Notte e Giorno
TORANO Notte e Giorno |
|
A
Torano, borgo di cavatori tra i più tipici
delle Alpi Apuane, nel mese di agosto si
vive la magia di una festa che vede
coinvolti artisti italiani e stranieri, con
un corollario di eventi musicali, spettacoli
e serate speciali dedicate alla degustazione
dei piatti tipici locali... |
|
|
|
|
 Fortitudo mea in coloris
Fortitudo mea in coloris |
|
A Carrara, nei
giorni del 30 e 31 luglio 2011, vari artisti che si dedicano
alla Street Art hanno coperto con le loro creazioni una
superficie di circa 120 mq in Via Donati, località stadio. Per
l'occasione è stato rivisitato il celebre motto cittadino
"Fortitudo mea in rota"... |
|
|
|
|
|
All'inizio del IV secolo d.C. il declino di Luni
venne determinato anche dalla concorrenza
commerciale di altre sedi dell'Impero e dal calo
della domanda dei marmi, dovuta alla pratica (che si
stava diffondendo) del loro reimpiego. Fu fatale
anche un violento sisma. In tono minore, Luni fu
abitata fino in epoca medievale (quando era sede
di diocesi) e definitivamente abbandonata agli inizi
del XIII secolo.
Alla sua scomparsa il marmo bianco
conobbe un periodo di appannamento. Le difficoltà di
trasporto contribuirono a lungo a minarne la
celebrità. |
 Il passaggio da Marmo di Luni a Marmo di Carrara
Il passaggio da Marmo di Luni a Marmo di Carrara |
Il Marmo di Luni tornò in auge
molti secoli dopo, con un nome diverso: "Marmo di
Carrara", il posto delle pietre, dei
carri, dei marmorari.
Carrara divenne sinonimo stesso del marmo, anche
oltre i confini dell'Italia. Prima dell'insediamento
di altre lavorazioni industriali, la città apuana
basò la sua economia essenzialmente sullo
sfruttamento delle cave e la lavorazione del
materiale lapideo.
Anche nel secolo scorso il marmo è stato un elemento
visibile e caratterizzante del paesaggio urbano.
Numerosi erano gli studi artistici, i laboratori, i
depositi.
Per raggiungere i pontili mercantili, i pesanti blocchi
venivano caricati su caratteristici carri trainati da
buoi che attraversavano Carrara lungo la
famosissima "Via
Carriona" (il nome deriva dal
torrente Carrione). Il Carrione (fluvius
Aventiae) non è un gran
fiume, ma le sue sorgenti sono nel cuore dei
giacimenti marmiferi, laddove esistono le cave più
famose e i marmi più pregiati. Sulle sue corte rive
(solo 12 Km) è stata veramente scritta la storia del
marmo, come ricordano i celebri versi di
Gabriele D'Annunzio:
"Dalla Grotta dei Corvi al Ravaccione - ferve
la pena e l'opera indefessa. Scendono in fila i buoi scarni
lungh'essa - l'arsura del petroso Carrione. S'ode
ferrata ruota strider forte - |
 |
|
Monumento agli Alpini |
|
sotto la mole candida
che abbaglia - e il grido del bovaro furibondo..."
Lungo il fiume Carrione,
dal 1891, si snodò la "Ferrovia
Marmifera", ritenuta
all'epoca un capolavoro di
ingegneria ferroviaria. Venne messa fuori
esercizio nel 1964, ormai soppiantata dal
trasporto effettuato con veicoli su gomma.
Del suo tracciato rimangono tutt'oggi alcuni
punti caratteristici. |
 |
|
Monumento a Giorgio Gaber |
|
|
Maestosi sono ancora i viadotti, meglio
conosciuti come "Ponti
di Vara".
Il più grande ha
un'altezza massima dal fondovalle di 38
metri e presenta cinque arcate a tutto
sesto, ognuna delle quali ha una luce di 16
metri. La zona è talmente suggestiva che è stata spesso
utilizzata come location per sfilate di
moda, presentazione di modelli di auto e i
minuti iniziali di un film della saga
"James Bond - Agente Segreto 007"
(vedi "Alpi Apuane 2"). Ogni anno, nel mese
di agosto, ai Ponti di Vara si svolge il
tradizionale appuntamento per la
rievocazione della
"Lizzatura Storica".
Nel corso dei secoli sono circa un
migliaio le cave sfruttate e poi dismesse.
Attualmente ne sono aperte poco più di un
centinaio, in un incessante lavoro di taglio
e trasporto che ha lasciato tracce
indelebili sui versanti montuosi.
Nell'antichità i marmi venivano segati
a mano, con grandi seghe, sul tipo
di quelle dei boscaioli (da qui il termine
dialettale «Buscaiol» riferito
al cavatore) e azionate da due uomini, uno di qua
e uno di là dal blocco, con un duro, estenuante
e monotono lavoro. La lama penetrava
lentamente nel blocco e per tagliare non si
avvaleva della dentellatura ma di una
miscela di sabbia e acqua versata via via nel
solco di taglio. |
|
|
|
 Come rendere ben levigata e lucente una scultura Come rendere ben levigata e lucente una scultura |
|
Il
marmo è un materiale molto poroso e
quindi assorbe facilmente quelle sostanze
che, volutamente o involontariamente, vi si
depositano sopra. Olio e caffè, per esempio,
sono micidiali nel produrre macchie
indelebili che disturberanno per sempre la
nostra vista.
Premesso quanto sopra, può essere utile
sapere che - oltre ad una lucidatura
effettuata con attrezzature meccaniche - per
rendere ben levigata e lucente una scultura
in marmo bianco può essere
adoperata la cera delle comuni candele.
Questo procedimento naturale è stato
utilizzato durante il "Simposio
Internazionale di Scultura a mano" che si
svolge ogni anno a Carrara ed |
|
|
è di una semplicità estrema.
Terminata la scultura, vi si sfrega sopra a
freddo una candela e poi si liquefa la cera
applicata utilizzando una pistola ad aria
calda. In questo modo la stessa penetra bene
nei pori del marmo per rimanervi |
|
|
stabilmente. La cera in eccesso viene poi rimossa con un panno.
Il lavoro può essere effettuato anche a caldo, ovvero si
accende lo
stoppino della candela e poi si applica
la cera fusa che cola. Così come si può scaldare
il fusto della candela, sempre con una pistola ad
aria calda, per passarlo in contemporanea
sulla superficie dell'opera. Tutto sta
all'abilità personale e all'ampiezza della
superficie da trattare.
Il risultato finale è davvero sorprendente
perché, come abbiamo potuto verificare di persona,
le sculture diventano brillanti e lisce al
tatto. Provare per credere..... |
|
|
Era un'operazione semplice e primitiva, già
risalente all'epoca della dominazione
romana quando i cosiddetti «sectores
serrarii» avevano l'incarico di
ridurre gli informi macigni staccati dalle
montagne nelle lastre dello spessore voluto.
Col trascorrere del tempo non fu mai del
tutto abbandonata, neppure a partire dal
Settecento quando entrarono in funzione le
segherie ad acqua (azionate da ruote mosse
da energia idrica di caduta). Agli inizi del
Novecento, quando il progresso tecnologico
aveva già dato vita alle segherie azionate
da motori a vapore e poi a energia
elettrica, esistevano ancora dei marmisti
che guadagnavano la giornata tagliando i
blocchi con la rudimentale segatura a
braccia. Un duro e stancante impegno che
richiedeva intere giornate e testimoniava
l'importanza che il fattore umano ha sempre
avuto nelle cave, nelle segherie e nei laboratori.
Il marmo di Carrara si distingue in vari tipi
a seconda dell'uso a cui è destinato: lo
"statuario",
puro, candido e facilmente lavorabile; il
"bianco
ordinario" a grana più grossa
e con qualche venatura grigia, utilizzato
soprattutto per i rivestimenti; il
"bianco
chiaro", di minor pregio
rispetto allo statuario, con lieve tendenza
al grigio-azzurro; il
"bardiglio",
che presenta dei colori ancora più
accentuati del precedente. |
 GABRIELE D'ANNUNZIO - "La montagna si piega gemendo"
GABRIELE D'ANNUNZIO - "La montagna si piega gemendo" |
Il 14 luglio del
1907 Gabriele D'Annunzio salì
sulle Apuane per assistere ad una straordinaria varata di marmo.
Dalle cronache dell'epoca si apprende che il poeta fu chiamato a dar
fuoco alla miccia che dislocò 190.000 mc. di marmo.
D'Annunzio, elegantemente vestito di bianco e col binocolo a
tracolla, era accompagnato dal pittore
Plinio Nomellini e dal marchese
Clemente Origo, |
 |
|
COLONNATA - La piazza centrale del borgo |
|
 |
|
COLONNATA - Le montagne della vallata |
|
|
celebre scultore fiorentino
e proprietario di una villa al Motrone, dove il poeta, suo ospite,
aveva scritto nel 1901 la "Francesca
da Rimini" e nel febbraio del 1907 la prosa
"Di un maestro
avverso" in memoria di
Giosuè Carducci, di cui aveva visitato la casa natale in
quel di Valdicastello.
Per l'occasione fu allestito anche un treno speciale che partì da
Monterosso alle 5,30 del mattino in direzione della
vallata di Colonnata dove doveva avvenire lo sparo, in una località detta "La
fossa del poeta". Lo spettacolo si preannunciava infatti
unico ed incantevole.
La mina a fornello fu caricata con 8.000 chilogrammi di
esplosivo (mai in Europa
si era impiegata una simile carica), superando enormi difficoltà
dovute all'altitudine (1200 metri) e agli accessi impraticabili che
resero necessarie cinque riprese per il trasporto del materiale.
Tanto era importante la mina allestita (calcolata pari a 24.000
Kg. di polvere pirica) che l'esplosione generò anche un
mini-terremoto limitato alla valle.
Al momento di accendere la miccia però Gabriele D'Annunzio era
irreperibile e fu sostituito da una "madrina" presente sul luogo.
Chi era insieme al poeta raccolse una sua frase che rimase celebre:
"La montagna si piega gemendo". |
 GUGLIELMO WALTON, imprenditore inglese del marmo
GUGLIELMO WALTON, imprenditore inglese del marmo |
|
A Monzone i blocchi di marmo calati dalle Apuane venivano lavorati
nella segheria Walton. Guglielmo Walton fu un intraprendente
industriale inglese, nato nel 1786 nella contea di York, che
stabilitosi a Carrara
(dove era console del proprio Paese) si dedicò con passione e
fortuna all'industria e al commercio dei marmi. Per
questo aveva fondato la società «Walton Goody & Cripps - London,
Bristol, Liverpool» |
 |
|
MONZONE - La collina del centro storico |
|
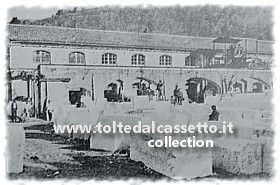 |
|
MONZONE - La segheria Walton Goody & Cripps |
|
|
che acquistò larga fama e vasta clientela
in breve tempo.
A metà dell'Ottocento Walton progettò e costruì a proprie spese un
pontile di legno per consentire l'attracco dei bastimenti a vela
alla Marina di Carrara. In questo modo vennero notevolmente
agevolate le operazioni di caricamento dei blocchi di marmo che in
precedenza avevano presentato notevoli difficoltà. Il pontile
caricatore era lungo circa 200 metri e largo 8 e
dotato di potenti gru (dette «mancine») capaci
di alzare blocchi di notevole mole e peso per poi
calarli nelle stive delle navi.
Un secondo pontile fu costruito nel 1871 ed un terzo verso la fine
dell'Ottocento, l'ultimo prima della progettazione del porto di
Marina di Carrara, i cui lavori di costruzione iniziarono negli anni
Venti del secolo scorso.
La società Walton estraeva il marmo dalle cave di Equi Terme e del
Monte Sagro. Oltre che a Monzone, possedeva altre segherie a
Carrara, nella zona della stazione di San Martino della
Ferrovia Marmifera (vedi "Alpi
Apuane 4"), nei pressi del ponte sul Carrione (appunto
chiamato anche «ponte Walton». Un altro stabilimento era ospitato
presso un palazzo ottocentesco dove una lapide ricorda il creatore
di quell'industria.
I marmi lavorati dalla società Walton vennero esportati in tutto il
mondo, parimenti a quelli di altri importanti laboratori che
operavano a Carrara.
Memorabile rimane il contributo alla costruzione della cattedrale di
San Alessandro a Sofia, in Bulgaria, alla cui realizzazione
collaborarono i migliori scalpelli della città. |
Sono stati
consultati:
Album delle Apuane
- a cura di Giorgio Batini -
Poligrafici Editoriale S.p.A. e Stampa locale;
Ufficio Stampa
de "APT - Massa Carrara" -
Ufficio Stampa de
"Con-vivere Festival";
QN - La Nazione
- "Spettacoli Toscana-Liguria" -
VIAGGITALIA
- Tuttotoscana - Editore Legenda srl
Segnaletica pubblica de
"Le Vie del Marmo"
- a cura dell'Associazione Comitato Pro Torano |
|
|
|