|
|
|
|
|
|
|
Archivio di grandi eventi
nazionali ed internazionali,
inchieste, reportages su
quotidiani e riviste celebri |
|
|
|
FINESTRE APERTE
SUL TERRITORIO |
|
 GENOVA
GENOVA
|
|
Il
capoluogo della Liguria
ha il centro storico più grande
d'Europa. Nel 2004 è stata la
"Capitale Europea della Cultura"... |
|
 EUROFLORA
EUROFLORA |
|
In
primavera, ogni 5 anni,
alla Fiera di Genova va in scena
lo spettacolo dei fiori per eccellenza.
I giardini più belli del mondo... |
|
 VIA FRANCIGENA
VIA FRANCIGENA |
|
Col
Giubileo del 2000 è stata
definitivamente rivalutata
la via di Sigerico, che i pellegrini
percorrevano a piedi fino a Roma,
in segno di pentimento... |
|
 PARCO DEL MAGRA
PARCO DEL MAGRA |
|
A
Gennaio 2008 il Parco Naturale
Regionale del Magra è il territorio
eco-certificato più esteso d'Europa... |
|
 GOLFO DELLA SPEZIA
GOLFO DELLA SPEZIA |
|
Tra la punta
di Portovenere e il Capo Corvo si apre una delle più
profonde insenature di tutto il litorale occidentale
italiano, declamata nei versi di illustri poeti e nella
quale è incastonata La Spezia, città sede di porto
militare e mercantile, che oggi è anche punto di
attracco per le navi da crociera... |
|
 LE CINQUE TERRE
LE CINQUE TERRE |
|
Cinque
borghi marinari il cui destino è sempre stato
storicamente legato alla terra e all'agricoltura
piuttosto che alla pesca. Un paradiso naturale della
Liguria che nel 1997 è stato inserito dall'UNESCO tra i
Patrimoni Mondiali dell'Umanità... |
|
 LA VAL DI MAGRA
LA VAL DI MAGRA |
|
Nobili,
vescovi, mercanti e pellegrini
lungo l'asse della Via Francigena.
Culture differenti per storia e tradizioni,
nei secoli, si sono sovrapposte
e hanno permeato il territorio con
i segni del loro passaggio... |
|
 LA VAL DI VARA
LA VAL DI VARA |
|
La
"Valle dei borghi rotondi"
è anche conosciuta come
la "Valle del biologico" per le sue
produzioni agricole ottenute con
metodi antichi e naturali.
Varese Ligure nel 1999 è stato il
1° comune ecologico d'Europa... |
|
 LA LUNIGIANA
LA LUNIGIANA |
|
La
"Terra della Luna", in Italia,
ha la più alta concentrazione di
antichi castelli. Se ne contano
circa 160. Alcuni sono bellissimi e
perfettamente conservati... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizione Colombo 1992 |
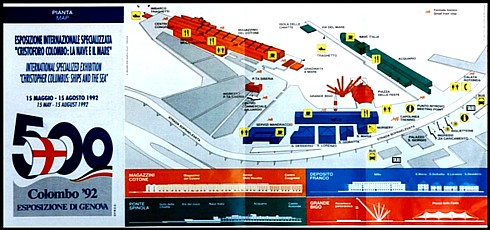 |
|
|
|
Porto Antico |
Columbus International Exhibition 1992 |
|
|
Le Colombiadi
del 1992 hanno consentito al capoluogo ligure un
notevole rilancio in campo internazionale e sono state
l'occasione per ammodernare aree urbane e portuali che
versavano in situazioni di abbandono o degrado. Una di queste è
quella del vecchio porto genovese o
Porto Antico,
oggi definita "La Piazza sul Mediterraneo",
di cui sopra è visibile una piantina con i primi interventi effettuati.
Il cuore della città cambiò radicalmente per fare posto ai padiglioni
dell'Expo, la vetrina internazionale che aprì i battenti il 15
maggio 1992 in onore del genovese più famoso del
mondo. Gru e cantieri dappertutto nel vecchio porto
per allestire la grande piazza futuribile che
avrebbe ospitato una rete di ristorazione interna e
luoghi di ritrovo e ricettività turistica come
l'Acquario (uno dei
più importanti del mondo con le sue 70 vasche e 6000
specie di animali acquatici), la
Bolla e il
Bigo (progettati dall'architetto genovese di fama internazionale Renzo Piano).
Quest'ultimo è un ascensore panoramico sorretto da imponenti
alberi e cavi metallici, capace di portare 65
persone alla volta ad un'altezza di circa 40 metri,
dalla quale si può ammirare ammirare il suggestivo panorama della città
"caratteristicamente "arrampicata"
sulle colline circostanti e del suo orizzonte portuale. |
|
|
Accanto alla zona fieristica, nella parte più
esterna dei Magazzini del Cotone fu costruito un Palazzo dei Congressi.
Nello specchio d'acqua antistante la piazza venne
allestito un porticciolo turistico.
Le "Colombiadi" furono anche un "pretesto"
per recuperare aree e restaurare palazzi del centro storico che si
affacciano alle spalle dello scalo genovese.
Un "make up" urbanistico e culturale gestito
dall'"Ente Colombo", |
 |
|
Gatto
Colombo |
|
società nata
dalla collaborazione tra la Regione Liguria, la
Provincia e il Comune di Genova, la Camera
di Commercio e il Consorzio Autonomo del Porto
di Genova. Per le opere edilizie e la
promozione |
 |
|
La
"nave tartaruga" |
|
|
pubblicitaria vennero stanziati
finanziamenti statali per quasi 600 miliardi
di lire.
All'epoca era necessario un rilancio
dell'immagine del capoluogo ligure in campo
turistico e non solo. Genova viveva infatti
da tempo una crisi difficile, con un
tasso di disoccupazione del 10%, ventimila
prepensionamenti nei 10 anni precedenti l'evento e
l'irrisolto problema dei lavoratori portuali
che costava allo Stato circa
1.000 miliardi di lire l'anno.
L'esposizione internazionale "Cristoforo
Colombo: la nave e il mare", durata
3 mesi, ospitò più di 40 tra Paesi e
organizzazioni. |
|
|
A tema il
rapporto dell'uomo con il mare nei suoi risvolti economici,
scientifici e tecnologici. Una storia della
navigazione, uno studio della vita dell'uomo
sul mare, con contenuti che hanno spaziato
da Colombo alla tecnologia più |
|
avanzata, dalla nave come
mezzo di scambi commerciali alla sua funzione di
veicolo turistico.
Celebrazioni in onore del marinaio genovese
si svolsero anche a Boston, signorile
metropoli dell'East Coast, cuore storico e
culturale degli Stati Uniti
d'America. Durante il Festival del Porto
(dall'1 al 5 luglio) vennero organizzati
numerosi concerti musicali, esibizioni,
spettacoli. |
 Le feste colombiane
del 1892 per il 400°
anniversario Le feste colombiane
del 1892 per il 400°
anniversario |
|
Le feste colombiane del 1892 celebrarono il 4°
centenario della scoperta dell'America e attirarono
su Genova gli occhi del mondo. Anche allora il
successo fu grande: moltissime nazioni manifestarono
la loro stima e amicizia per l'Italia inviando le
loro navi da guerra in porto, per una straordinaria
adunata. Tra le più importanti e vaste
manifestazioni di Colombo 1892 si possono anche
ricordare: un immenso recinto in Piazza di Francia,
con mostre, locali pubblici, divertimenti; la visita
dei Reali d'Italia; l'inaugurazione del Castello
Raggio, il varo di una nave.
A Palazzo Reale i Sovrani esternarono al
sindaco di Genova, barone Podestà, la loro più viva
soddisfazione per la straordinaria accoglienza e per
le imponenti dimostrazioni di affetto ricevute dalla
cittadinanza, |
|
|
tanto nell'entrata in porto, quanto
nel percorso veramente trionfale dal ponte di
sbarco al palazzo di Via Balbi.
Lo spettacolo fu grandioso, imponente ed
inaspettato: nella sola Piazza Carlo Felice
e Via Roma ci saranno state per lo meno
40.000 persone, pigiate, strette come tante
acciughe e nell'assoluta impossibilità |
|
di fare un passo avanti. Le carrozze erano chiuse da questa
"morsa vivente" e nonostante le preghiere e gli scongiuri
dei vetturini, era quasi impossibile procedere innanzi.
Altrettanto accadeva in Via Sellai per le
vetture dirette al Carlo Felice, nella
discesa di Via Roma e in principio di
Piazza Fontane Marose dove era stato completamente
sospeso, da tutte le parti, ogni servizio di tram e omnibus.
Il porto risplendeva, dardeggiando grandi fasci di
luce sull'infinito piano del mare. Tutte le navi
delle squadre, tutti i piroscafi, tutti i bastimenti
erano festosamente illuminati. Dalle più grandi
corazzate degli enormi fari di luce elettrica, a
sbalzi, a sprazzi, inondarono di luce vivissima i
punti più stupendi della città.
Trattandosi di festeggiare il quarto centenario di
quel grande navigatore italiano di Liguria, non era
fuor di luogo escogitare qualcosa di esclusivo, che
suscitasse meraviglia nei visitatori.
La ditta vinicola Quarone, Gaiato e Comp. di Torino
si inventò per la Colombiana 1892 l'«Uovo di Colombo».
Si trattava di una costruzione, appunto a forma di
uovo, alta circa 26 metri e posta sulla vasta
tavola-terrazzo di 500 mq. di superficie, situata
sulla spianata del Bisagno, nel Parco
dell'Esposizione. L'interno era adibito a
ristorante, benissimo aerato ed illuminato da 16
finestre ed un lucernario. Internamente l'«Uovo
Ristorante» era suddiviso in 4 piani, ai quali si
accedeva con una comoda e larga scala in legno. Le
quattro sale di ristorazione erano state
egregiamente colorate dal pittore Rizzola di Torino
ed ornate altresì di pregiati specchiere e quadri. |
|
|
|
|
|
|
Dieci giorni dopo
centinaia di imbarcazioni approdarono nel porto della città da
tutto il mondo, per uno spettacolare raduno. Anche a Siviglia,
nella cui cattedrale sono contenute le spoglie del grande
navigatore, l'avvenimento fu occasione per grandi solennità
(vedi
pubblicità Siviglia Expo 1992). |
|
●
Il porto di Genova dopo la Prima Guerra Mondiale |
Negli anni del dopoguerra 1915-18, il
porto di Genova era già il primo porto commerciale
d'Italia e, per il traffico di navi e il movimento
delle merci, poteva essere considerato anche il
primo del Mediterraneo. Tutta l'Italia
Settentrionale, la Svizzera e la Germania
Meridionale, avevano il loro sbocco naturale a
Genova. Perciò tutto il loro traffico si riversava
in questo porto che acquistava sempre maggiore importanza.
La zona portuale era divisa in avamporto e porto con
la darsena. All'avamporto, Molo Duca di Galliera, si
ormeggiavano i piroscafi in attesa di accosto, le
navi da guerra, quelle a lungo disarmo, nonchè
quelle cariche di infiammabili ed esplosivi; mentre
quelle in demolizione, allestimento e riparazione si
attaccavano ai moli terranei.
Il Molo Nuovo era stato progettato nel
Seicento dall'arch. De Mari. Questa
ragguardevole realizzazione tecnica aveva due
funzioni: potenziare la ricettività portuale e
rendere lo scalo genovese più sicuro contro le
tempeste che fino a quel momento avevano, a più
riprese, gravemente danneggiato le sue strutture.
Liberata la rada dalla furia del vento, venne creato
il "porto franco" per far fronte alle sempre
crescenti esigenze di aree, proporzionali al
dilatarsi dei volumi dei traffici e degli
insediamenti urbani oltre la tradizionale cinta murria.
In questo modo si voleva anche rintuzzare la
pericolosa concorrenza di Livorno e Marsiglia.
La forma portuale rimase nel tempo quella
iniziale, sia pure con le inevitabili
modifiche e ristrutturazioni operate per necessità.
A cavallo fra Ottocento e Novecento si progettarono
e realizzarono nuove opere portuali: vennero
costituiti i Magazzini Generali del Molo Vecchio e
il silos cerealicolo alla Calata Santa Limbania;
furono installati gli elevatori per lo scarico dei
carboni al Ponte Paleocapa. Risale al periodo fra il
1903 e 1922 l'installazione di 21 elevatori
elettrici per lo sbarco dei carboni ai ponti
Assereto |
|
e Caracciolo. Il porto propriamente detto, si
componeva di sporgenze chiamate ponti e di calate
fra i ponti, che dal Molo Vecchio
andavano fino al Ponte Paleocapa.
Il Molo Vecchio risale al XIII° secolo ed
inizialmente era solo un robusto terrapieno che
saldava numerose catene di scogli. L'opera venne poi
completata ed irrobustita da Marino Boccanegra nel
1283, mediante la costruzione di solide murature.
Il porto di Genova aveva una |
|
|
|
Il porto negli anni Venti |
|
|
superficie acquea di 94 Km², con fondale di 9 metri
in media, che si manteneva pressoché costante per la
mancanza di sbocchi di fiumi.
Una parte, dal Ponte Assereto al Paleocapa, era
destinata appunto allo scarico dei
carboni minerali effettuato, oltre che a
spalla con coffe dai "camalli"
(antica consuetudine), anche per mezzo di
25 macchine automatiche, che potevano sbarcare
complessivamente una media di 800 tonnellate all'ora.
Lo sbarco dei cereali veniva fatto al Ponte
Parodi, per mezzo dei silos, aventi una
capienza di 45 mila tonnellate e che tramite
aspiratori potevano sbarcare 450 tonnellate l'ora,
lavorando a 6 diverse partite.
Il petrolio e la nafta erano riposte in due grandi
serbatoi con capacità di 6.800 m³, con modernissime
condutture per lo sbarco e l'imbarco.
Il porto di Genova era fornito di 3
bacini di carenaggio con annessi
stabilimenti per la riparazione delle navi.
Vi era pure uno scalo ferroviario a Santa
Limbania, la cui stazione era posta in
collegamento con la Stazione di Porta
Principe, alla quale facevano capo tutte le
linee ferroviarie che circondavano il porto
per spingersi sulle calate e sui ponti. |
|
La famiglia reale inglese nel porto di Genova |
|
|
Il 20 marzo del 1925 i Reali
d'Inghilterra giunsero a Genova in
treno per imbarcarsi sul loro yacht
"Victoria and Albert". Il passaggio
avvenne in forma strettamente privata |
|
per le non buone condizioni di salute di Re
Giorgio. Nella fotografia si vede il
panfilo mentre sta lasciando il
porto di Genova. |
|
Dall'archivio de "Il Secolo XIX" |
|
L'arrivo e la partenza dei piroscafi
che trasportavano passeggeri ed emigranti
(ndr.) avveniva al Ponte dei Mille,
esclusivamente riservato a questo scopo.
Tutte le calate e i ponti erano forniti
complessivamente di un centinaio di gru
idrauliche ed elettriche, per imbarco e
sbarco di mercanzie, capaci di sollevare 1,5
tonnellate. Mentre in punti fissi c'erano
gru idrauliche triple, per i grossi pesi.
In quegli anni Genova, per l'importanza del
suo scalo marittimo, era sede di quasi tutte le
Società di Navigazione Italiane e aveva
molte rappresentanze di Compagnie estere.
Genova era punto di partenza delle linee con rotta
per il Levante, per l'Estremo Oriente, per
le Americhe, per il Nord Europa, nonché per i
servizi postali minori con destinazione la Sardegna.
Facevano scalo a Genova l'olandese "Neederland"
per l'Estremo Oriente, le inglesi "White Star Line",
"Cunard",
"Anchor Line", ed altre
con traffici transoceanici. |
|
|
|
In una fotografia del 1932, da sinistra i
transatlantici "Rex", Conte di Savoia" e
"Conte Grande" ormeggiati alla stazione
marittima di Genova. Il 16 agosto del 1933
il "Rex" conquistò il "Nastro Azzurro",
compiendo la più veloce traversata d'ogni
tempo del Nord Atlantico, in 4 giorni, 13
ore e 50 minuti. (archivio "Il Secolo XIX") |
Negli anni '20, chiuse le ferite della
Prima Guerra Mondiale, il movimento
delle merci si era assestato a circa 5
milioni di tonnellate; le navi in arrivo e
partenza superavano le 7.500 unità, con un
movimento di quasi 100.000 passeggeri, dei
quali più di un 80% erano emigranti (ndr.).
Nonostante le difficoltà finanziarie,
continuarono le opere di ampliamento
dell'area portuale che in futuro avrebbe
abbracciato anche la zona di Sampierdarena.
In corso di progettazione la Stazione
Marittima al Ponte dei Mille, la cui
necessità impellente era quanto mai sentita.
I lavori di costruzione dello scalo
passeggeri vennero poi ultimati nel 1930. |
 Fonti: vedi pagina principale
"Genova Home"
Fonti: vedi pagina principale
"Genova Home" |
|
|
|
|
Close Up |
|
Fotografie, eventi, turismo,
personaggi, arte e cultura |
|
Il dialetto genovese
Le trasformazioni
fonetiche avvenute nella parlata di Genova sono un segno
inequivocabile del dinamismo espresso dalla città durante i
secoli della Repubblica. A Genova il dialetto è una lingua viva,
che oggi viene insegnata anche nelle scuole... |
 |
|
Funicolari e Ferrovia
A Genova effettua
servizio una delle tranvie a cremagliera più antiche d'Italia,
che collega la zona della Stazione Principe con il quartiere
collinare di Granarolo. Assieme alle altre funicolari consente
di accedere a punti panoramici per vedere la città dall'alto.... |
 |
|
Teatro popolare e di strada
Le esibizioni
teatrali in strada hanno origini molto remote. Le prime notizie
di giocolieri e saltimbanchi risalgono addirittura all'antico
Egitto. Nel 2004 il comune di Genova ha riconosciuto l'arte di
strada come fenomeno culturale e ha regolamentato la materia... |
 |
|
Il principe Andrea
Doria
L'abilissimo
ammiraglio genovese diventò ricco e potente, ma non perse mai
quelle caratteristiche morali che lo avevano contraddistinto fin
da giovane. In una sua biografia si legge: "Aveva aspetto
eroico, gravità virile e gesto umano... il sobrio vivere e il
suo parco vestire non erano da principe ma da privatissimo
gentiluomo..." |
 |
|
Cristoforo Colombo
Uscito
dall'adolescenza cominciò ad interessarsi ai viaggi di mare,
dedicandosi con amore agli studi geografici ed assecondando in
tal modo la sua naturale inclinazione per le ricerche
scientifiche. Convinto della rotondità della Terra, partì da
Palos il 3 agosto 1492 per la scoperta di nuovi mondi... |
 |
|
Alluvioni in Liguria dal 1894
In Liguria i
disastri legati al
maltempo sono determinati da
tanti fattori. Alluvioni e
devastazioni operate da corsi
d'acqua impazziti, violente
mareggiate e frane sono da
sempre una costante del territorio... |
 |
|
Liguria regione ad elevato
rischio idrogeologico
Secondo uno studio di
Legambiente in Liguria sono
molti i territori che risultano
fragili ed esposti ad un elevato
rischio idrogeologico... |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|