 |
Finestre fotografiche su Liguria e Toscana |
L'occhio della
macchina fotografica |
|
|
|
|
|
|
 L'obiettivo
normale, un prezioso e universale strumento di lavoro L'obiettivo
normale, un prezioso e universale strumento di lavoro |
Il celebre fotografo francese Henri Cartier Bresson sosteneva che
l'ottica normale è l'unica realmente utile nelle riprese
fotografiche. Un obiettivo normale è quello che, in base al formato
utilizzato, restituisce nel modo più fedele la «geometria della
realtà» ed è anche quello che si adatta meglio ad ogni situazione di ripresa.
Nel formato 35 mm, esempio reflex digitali con sensore full-frame,
viene considerata normale un'ottica che ha una lunghezza focale
compresa tra i 45 e i 58 mm. L'obiettivo «normale» per eccellenza
è il classico 50 mm.
Coerentemente con questa visione delle cose, Cartier Bresson
ricorreva molto raramente ad altre focali, anche perché riteneva che
un fotografo che si trascina appresso pesanti e complicate
attrezzature |
|
|
non può essere pronto a scattare la foto nel momento
decisivo. Per questo motivo il corredo chesi portava appresso
era costituito da una Leica col 50 mm e da una specie di nécéssaire da
viaggio, piccolo e compatto, con dentro anche un medio-tele da
90 mm, alcuni rullini e un foglietto per prendere appunti. Questa
attrezzatura poteva stare comodamente nelle tasche di un giubbotto.
E' abbastanza ovvio che ogni fotografo che si rispetti sceglie
l'obiettivo in funzione di ciò che vuole riprendere, e non
viceversa. Pertanto se Cartier |
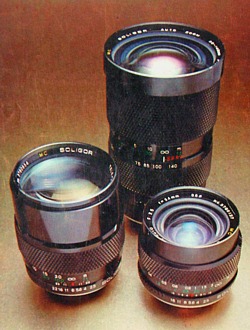 |
|
Un corredo di
obiettivi per reflex |
|
Bresson esaltava l'ottica standard lo
faceva perché questa si adattava perfettamente al genere di
fotografie che lui prediligeva.
Ai tempi della fotografia analogica
l'ottica standard era considerata il primo
passo necessario prima di passare ad altri obiettivi (il cui
acquisto veniva sempre soppesato con molta cura), pur essendo
possibile, in alcuni casi, acquistare il solo corpo macchina di una reflex.
Oggi lo sviluppo tecnologico e l'avvento del digitale nel campo
delle macchine fotografiche ha dato spazio ad un uso massiccio degli obiettivi a
focale variabile (zoom), che solitamente vengono venduti come
corredo standard delle reflex. Questo ha aperto nuovi orizzonti alla
creatività dei fotografi ma ha anche determinato un cambiamento non
trascurabile dell'«atteggiamento» fotografico.
Infatti con una reflex dotata di un obiettivo fisso se io voglio avere una visione
più ravvicinata della scena da riprendere devo spostarmi in
direzione dei soggetti. L'utilizzo di uno zoom invece è facile che
«impigrisca» il fotografo, il quale non si sposta per niente potendo
aumentare a piacimento la focale. L'immagine catturata non è però la
stessa perché la prospettiva di scatto è diversa.
E' accertato che per i ritratti, le foto di matrimonio, le
foto di reportage, nella maggior parte dei casi può essere
sufficiente l'utilizzo di un solo obiettivo fisso «normale».
E' altresì perfettamente vero che molte delle attuali tecniche di
ripresa fotografica sono consentite solo da particolari tipi di
obiettivi e che molti soggetti non potranno mai dare risultati di un
certo interesse se ripresi con un'ottica «normale», ma è anche vero
che soltanto pochi - anzi pochissimi - degli infiniti tipi di
obiettivi oggi in commercio potranno essere usati da un fotografo
non professionista in modo utile, continuativo e soddisfacente.
Purtroppo, mentre il fotografo veramente «creativo» riesce a
lavorare con un solo obiettivo, in ogni situazione, riuscendo a
realizzare immagini sempre nuove e interessanti, la maggior parte di
noi non è in grado di fare altrettanto e soccombe al richiamo
allettante di ottiche supplementari.
Non dimentichiamoci comunque che se da un lato il mondo delle
ottiche intercambiabili e degli zoom può dare veramente una nuova e
concreta dimensione al nostro hobby, dall'altro può giungere a
frustrarci completamente.
Una larga parte degli obiettivi che vengono venduti annualmente
finisce - dopo i primi entusiasmi - in un cassetto o in un armadio,
in seguito ad un'errata valutazione al momento dell'acquisto. Per
risolvere questo problema basterebbe un serio ed onesto esame delle
nostre esigenze, una valutazione precisa dell'uso che nell'arco di
un anno potremo fare di una certa ottica, tenendo in debito conto il
suo costo, per stabilire se valga o meno la pena di acquistarla. |
|
 Lunghezza focale e cerchio di copertura
Lunghezza focale e cerchio di copertura |
|
Una lente convergente fa si che i raggi del sole vadano a
finire tutti in un solo punto, estremamente luminoso, che costituisce
l'immagine dell'astro fornita dalla lente usata come obiettivo. Un obiettivo
fotografico non è altro che un gruppo di lenti, a volte molto complesso,
perché formato da elementi di caratteristiche e struttura diverse, che si
comporta come una singola lente convergente. Ogni ottica |
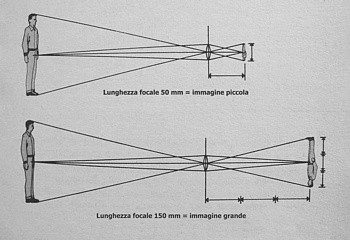 |
|
Dimensioni
dell'immagine al crescere della focale |
|
ha una sua precisa lunghezza focale.
Questo termine è usato per indicare la distanza tra il centro ottico
(pressapoco) dell'obiettivo e il piano focale della macchina fotografica,
quando la messa a fuoco è impostata sull'infinito.
Focale e grandezza dell'immagine sono direttamente proporzionali: un
obiettivo di focale doppia di un altro produce un'immagine due volte più grande.
La particolare curvatura delle lenti di un obiettivo fotografico fa si che i
raggi luminosi giungano su un piano ben definito - chiamato appunto «piano
focale», posto dietro l'obiettivo stesso. Il calcolo della curvatura delle
lenti determina sia la lunghezza focale che l'angolo di campo. |
|
|
L'immagine fornita da un obiettivo è rotonda, ma di qualità non uniforme:
la nitidezza diminuisce man mano che ci si sposta dal centro verso l'orlo e
le zone vicino all'orlo sono inutilizzabili. Affinché la stessa possa
coprire completamente un fotogramma bisogna perciò che il suo formato
rientri dentro quello che viene definito «cerchio di copertura». Vale
a dire, per esempio, che un'ottica progettata per il
formato reflex digitale 24x36 con sensore full-frame deve
formare un'immagine circolare il cui diametro minimo
sia pari a 43 mm. Nel formato 6x6 la lunghezza di questo diametro sale a
circa 80mm. Misure inferiori a quelle innanzi indicate darebbero luogo al
fenomeno della vignettatura: l'immagine si presenterebbe cioè curva e
meno luminosa agli angoli. Gli obiettivi che troviamo comunemente in
commercio possono soffrire di questo difetto. |
|
 Elementi, gruppi ottici
e altri fattori di progettazione Elementi, gruppi ottici
e altri fattori di progettazione |
Un obiettivo fotografico è un
gruppo ottico positivo paragonabile ad una lente biconvessa. Per
evitare le aberrazioni che una sola lente comporterebbe, gli
obiettivi risultano formati da un numero variabile di elementi
ottici di varia forma e composti da vari tipi di vetro ottico.
Non esiste un numero limite alla quantità di lenti che lo devono
formare. E' però fisicamente |
|
dimostrato che risultati
accettabili si ottengono solo partendo da un numero minimo di tre elementi.
Nella progettazione di un obiettivo è necessario tener presente vari
fattori come: la lunghezza focale del gruppo ottico, la sua
luminosità massima, il grado di contrasto e nitidezza e la
correzione alle aberrazioni che si desidera ottenere.
Ogni obiettivo rappresenta un compromesso fra questi vari fattori
perché è praticamente impossibile ottenere un obiettivo perfetto.
Oggi, grazie all'aiuto fornito dagli elaboratori elettronici, |
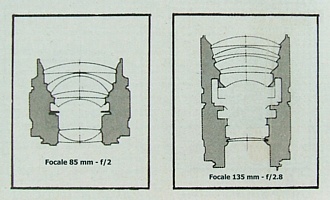 |
|
Lenti e gruppi
di un 85 mm e di un 135 mm |
|
|
il tempo di progettazione
di un'ottica può richiedere solamente pochi minuti e i
costruttori possono sfornare obiettivi di buona qualità
senza troppa fatica. Invece prima dell'avvento dell'era elettronica
lo studio di un obiettivo era frutto di lunghi calcoli matematici ottenuti a
tavolino, che potevano richiedere anche anni
di lavoro. Un obiettivo risulta più o meno buono in base ai risultati che ci
consente di ottenere. Un maggior numero di lenti nella composizione
di un obiettivo fotografico non determina assolutamente una migliore
qualità ottica. Pertanto, nella scelta di un obiettivo, non bisogna
prestare troppa attenzione a questo fattore.
Questo anche perché il numero elevato delle lenti
può comportare vari difetti come, ad esempio, la perdita di
nitidezza dovuta ai riflessi interni generati dai raggi luminosi
quando attraversano gli spazi fra una lente e l'altra.
Teoricamente, c'è nitidezza quando una fonte luminosa puntiforme (per esempio
una stella) è registrata sul sensore in forma di punto. In pratica, naturalmente,
questo è impossibile perché anche la stella più piccola non è mai
resa in forma di punto (che ha un diametro pari a zero) ma in forma
di un disco. Parimenti, l'immagine di un qualsiasi oggetto non
consiste di un infinito numero di punti, ma di un numero infinito di
microscopici cerchietti con gli orli sovrapposti, che si chiamano
«cerchi di confusione». Quanto più piccoli sono i cerchi di
confusione, tanto maggiore appare la nitidezza. Di conseguenza la
nitidezza è sempre una questione di grado, poiché la nitidezza
«assoluta» è un assurdo.
Grazie ad una accurata progettazione, gli schemi ottici dei moderni obiettivi possono essere molto
semplici ma, allo stesso tempo, garantire un'altissima qualità
dell'immagine ottenuta. |
|
 La luminosità elevata non è sinonimo di migliore qualità
La luminosità elevata non è sinonimo di migliore qualità |
|
Un altro mito
da sfatare nella fotografia è quello della luminosità
massima degli obiettivi. Comunemente si è portati a credere che
paragonando due ottiche di uguale focale, quella più luminosa sia
migliore dell'altra. Questo è falso anzi, solitamente, è vero il
contrario perché gli obiettivi di notevole luminosità presentano una
realizzazione tecnica più complessa, che può dar luogo a vari
difetti indesiderati. Un solo diaframma in più sovente viene
ottenuto con molte correzioni ottiche, che non sempre sono
realizzate in modo perfetto. |
La luminosità di un obiettivo non è assoluta, ma dipende
dalla sua distanza dal soggetto. Quando si mette a fuoco un soggetto molto vicino,
la distanza fra obiettivo e sensore aumenta in misura tale che la
conseguente perdita di luminosità deve essere compensata da un
proporzionale aumento di posa, pena una considerevole sottoesposizione.
La luminosità massima di un obiettivo viene calcolata dividendo il
diametro della lente frontale per la lunghezza focale. Per questo
motivo i teleobiettivi molto luminosi hanno una lente frontale di
diametro enorme. Ottenere grandangolari luminosi è relativamente più
facile, ma una luminosità accentuata comporta numerose aberrazioni
difficili da correggere.
In genere le focali più lunghe hanno una luminosità massima
relativamente più bassa in quanto le dimensioni della lente
anteriore rappresentano un limite non trascurabile.
Per chiarire meglio il concetto, un obiettivo 50 mm f/1.8 richiede
un elemento frontale di circa 32 mm di diametro, e questo è
possibile senza alcun problema. Ma un ipotetico 500 mm f/1.8 avrebbe
bisogno di una lente anteriore con diametro di circa 1100 mm (un
metro!). La realizzazione di un'ottica del genere richiederebbe
tante di quelle correzioni che ne
porterebbero il prezzo alle stelle. E come si potrebbe andare in
giro a fotografare con un obiettivo così grande e pesante...!
"Gli obiettivi molto luminosi hanno maggiori difetti, sono più pesanti
e più grossi e - neanche a dirlo - più costosi degli obiettivi di minore luminosità,
sono generalmente meno incisivi, anche a piccole aperture di
diaframma. Per avere sufficiente profondità di campo, la gran parte
delle fotografie vengono scattate con una chiusura di almeno due
stop rispetto alla massima. Perché allora non usare obiettivi meno
luminosi e più incisivi e ottenere fotografie nitide invece che
subire gli inconvenienti degli obiettivi più luminosi solo perché si
prevede che la loro «rapidità» sia utile di tanto in tanto?
E' come comprare un camion invece di un'automobile col pretesto che, un
giorno o l'altro, potrebbe far comodo per un trasloco". (Andreas
Feininger). |
|
 Classificazione
degli obiettivi diversi da quelli «normali» Classificazione
degli obiettivi diversi da quelli «normali» |
|
Nel prendere in esame le varie categorie di obiettivi qui sotto esposte
è necessario premettere che alcuni parametri devono essere per comodità riferiti all'uso
di una reflex digitale 24x36 (sensore full-frame). Nel caso in cui la
superficie del sensore sia minore bisogna tenere in conto che l'angolo di
campo dell'obiettivo utilizzato diminuisce. Un'ottica «normale» da 50mm
diventa pari ad un medio-tele. Questo ci consente un «esame» più selettivo
dell'ambiente che ci circonda e la profondità di campo diminuisce. |
 I grandangolari
I grandangolari |
Gli obiettivi con lunghezza focale inferiore a quella
delle ottiche cosiddette «normali» vengono definiti grandangolari.
Rientrano in questa categoria tutte quelle ottiche che hanno un angolo di
campo superiore ai 47°. I grandangolari prodotti per macchine fotografiche
24x36 sono, in genere, contraddistinti da focali comprese tra i 13 ed i 35
mm. Le focali più corte di 13 mm rientrano nella categoria dei «fish-eye»,
obiettivi del tutto particolari, con distorsioni veramente considerevoli e
di interesse limitato. Il loro nome deriva dal fatto che la forma della loro
lente frontale è rotonda e sporge abbondantemente dall'obiettivo, come
l'occhio di un pesce appunto, consentendo di abbracciare un campo pari o
superiore ai 180°.
Il grandangolo è un tipo di obiettivo molto utilizzato nelle foto
urbanistiche e nei paesaggi, dove le scene da fotografare sono
necessariamente ampie. Mal si presta alle fotografie di persone (soprattutto
ritratti) in quanto l'avvicinamento al soggetto produce una spiacevole
distorsione prospettica.
"Il grandangolo è un obiettivo che deve essere usato con
un pizzico di coraggio: l'enorme campo inquadrato da la possibilità
di entrare, a volte anche con prepotenza, negli scenari di
una città, nelle strutture architettoniche, per scoprire quei segni e quegli
oggetti che sono propri dell'ambiente urbano. E' uno strumento con il quale
non bisogna curiosare da lontano, dal di fuori delle cose, così come si fa
quando si «spia» il mondo con i lunghi tele da paparazzo. Si tratta invece
di un obiettivo che deve essere portato nei luoghi del proprio interesse e
che deve essere adoperato con la stessa sensibilità con la quale si osserva
prima ancora di fotografare". (Massimo Alario) |
La ridotta lunghezza focale di un grandangolo ci
assicura una notevole profondità di campo, anche a forti aperture di
diaframma. Per esempio un 28 mm, diaframmato a f/3.5, ci consente una
profondità di campo uguale a quella che con un 50 mm potremmo avere
solamente chiudendo l'apertura a f/8, a parità di superficie inquadrata. E
inoltre, dal momento che il grandangolo è caratterizzato da una ridottissima
distanza di messa a fuoco (generalmente dai 20 ai 30 cm), possiamo benissimo
utilizzarlo per foto a distanza molto ravvicinata senza dover ricorrere a
dispositivi di prolunga, riempiendo tutta l'area inquadrata con il soggetto prescelto.
L'angolo di campo di un «fish-eye» o «occhio di pesce» non consente
assolutamente la corretta riproduzione delle linee rette e quindi tutta
l'area del fotogramma presenterà una distorsione a «barilotto». Le sue
focali estremamente corte generano delle riprese «circolari» che trovano
applicazione scientifica, per esempio nella meteorologia.
I grandangolari sono obiettivi «difficili» e quindi soggetti più degli altri
a difetti e aberrazioni (che possono essere particolarmente evidenti a tutta
apertura) come la vignettatura, l'aberrazione sferica e il coma. Questi
problemi si risolvono chiudendo il diaframma di uno o due valori,
utilizzando cioè l'ottica nel punto in cui «lavora» meglio. |
|
Il grandangolo è insuperabile come versatilità, ma per apprezzarlo
bisogna sfruttare al massimo le sue caratteristiche di profondità e nitidezza. Per quanto mi
riguarda, come ottica fissa standard, da sempre preferisco utilizzare un
grandangolare da 28 mm, che per me è l'obiettivo per eccellenza.
Solitamente dentro ci sta sempre tutto, al contrario del 35 mm o del
50 mm che spesso qualcosa lasciano fuori... |
|
Il primo 28 mm per il formato 24x36 ad ottica intercambiabile
fu il Tessar Zeiss di luminosità f/8 per le fotocamere Contax.
Questo obiettivo venne progettato nella seconda metà degli anni
Trenta del secolo scorso ed era composto da 4 lenti raccolte in 3
gruppi, aveva una montatura in ottone e pesava solamente 130 grammi. |
|
Il primo 28 mm per apparecchi reflex, con mantenimento
del movimento dello specchio, fu l'Angenieux Retrofocus f/3,5 a 6
lenti, di cui due frontali divergenti. Questo grandangolare fu
realizzato in Francia, nel dopoguerra, da P. Angenieux sulla base
degli studi fatti da Ricter durante la seconda guerra
mondiale con la sua ottica sperimentale Pléon. Lo schema
dell'Angenieux Retrofocus fu poi ripreso dai produttori della
Pentax per il Takumar 28 mm f/3,5. |
|
 I teleobiettivi
I teleobiettivi |
Rientrano nella categoria dei
teleobiettivi tutte quelle ottiche il cui angolo di campo è inferiore ai 47°
di un obiettivo «normale». Una delle caratteristiche tipiche dei teleobiettivi è il
fenomeno dell'appiattimento delle distanze che fa apparire vicini due soggetti in
fila che, nella realtà, possono essere molto distanti fra loro.
Statisticamente parlando il teleobiettivo è l'ottica più
richiesta subito dopo l'acquisto di un apparecchio fotografico corredato con
ottica standard. Questo fenomeno è particolarmente evidenziabile quando ci si
trova a fotografare avvenimenti ove sono presenti numerose persone
che hanno al collo la macchina fotografica. E' difficile, in questi casi,
vedere delle riprese effettuate con obiettivi grandangolari.
Il tele ha un fascino tutto particolare: ci proietta dentro gli eventi anche se
ci troviamo a notevole distanza e, per le sue dimensioni, colpisce immediatamente gli
occhi dei profani, dando l'impressione (ovviamente errata) che ci si
trovi di fronte ad un fotografo professionista o comunque molto bravo.
Insomma fa molta scena...
Fatti salvi gli usi strettamente specialistici (foto sportiva,
naturalistica ecc.), i grandi professionisti dell'immagine non hanno mai particolarmente
apprezzato questo tipo di ottiche. Sentite come si esprimeva sull'argomento
Henri Cartier Bresson, tirando in ballo un illustre collega: "Il tele non
dice la verità. L'obiettivo ideale è il 50 mm perché, come era solito
ripetere Robert Capa, un fotografo deve stare vicino alla gente".
Il primo impatto con un teleobiettivo è veramente emozionante. E' come
guardare con un nuovo paio di occhi cose già familiari. Il poter frugare
lontano, nel mondo che ci circonda, ci dà un senso di euforia. Si scoprono
cose che normalmente ci sfuggono: atteggiamenti dettagli, fisionomie, espressioni.
Un tele moderato si aggira tra gli 80 e i 135 mm di lunghezza focale, un
medio tele tra i 150 e i 200 mm, un tele di azione tra i 300 e i 600 mm.
Oltre si entra nel mondo dei super tele per usi specialistici, che sono di
dimensioni e di peso tale da renderne problematico il trasporto ed hanno
bisogno sempre di un appoggio ben stabile (anche se di fortuna) per poter
essere utilizzati senza incorrere nell'effetto mosso.
Nelle foto sportive e naturalistiche il teleobiettivo la fa da padrone: il
suo utilizzo è quasi indispensabile. Quando si fotografa in spazi molto ampi
un'ottica da 200 mm può essere considerata alla stregua di un obiettivo
normale. Pertanto per fotografare degli animali selvatici nel loro ambiente
naturale un 300 mm è un tele appena passabile. In questi casi è preferibile
utilizzare un'ottica con focale non inferiore ai 500 mm.
Chi non ha particolari esigenze specialistiche, ma desidera un teleobiettivo
che possa soddisfare la maggioranza delle sue esigenze, potrà trovare
l'optimum in un 135 mm; per delle belle riprese sportive può essere già
sufficiente una focale di 200 mm.
Una delle caratteristiche tipiche dei teleobiettivi è il fenomeno
dell'appiattimento delle distanze che fa apparire vicini due soggetti in
fila che, nella realtà, possono essere molto distanti fra loro. |
Le focali medie 85 e 105 mm sono ideali per i ritratti, perché sono
pressoché totalmente esenti da distorsioni prospettiche, anche alla minima
distanza di ripresa. Mentre un grandangolare ritrae il soggetto immerso nell'ambiente che
gli è congeniale, mantenendo uno stretto rapporto fra macchina fotografica e persona, un
teleobiettivo può isolare il soggetto dallo sfondo, oppure avvicinare lo
sfondo creando un diverso rapporto spaziale.
Più si allunga la focale, più viene esaltata qualsiasi minima vibrazione del
complesso fotocamera/obiettivo. Per non incorrere in immagini mosse bisogna
diminuire i tempi di esposizione e/o fare uso di un robusto cavalletto.
Inoltre si moltiplicano i problemi di correzione ottica, come ad esempio
l'aberrazione cromatica, con conseguente perdita di nitidezza dell'immagine.
Questo fenomeno è particolarmente evidenziabile con i teleobiettivi zoom:
alla focale minima le fotografie risultano più incisive e contrastate che
non impostando quella massima. |
 Gli obiettivi catadiottrici, chiamati anche «obiettivi a specchio»
Gli obiettivi catadiottrici, chiamati anche «obiettivi a specchio» |
|
I teleobiettivi, data la loro costruzione ottica, hanno lo
svantaggio di essere lunghi all'incirca quanto la loro lunghezza focale. Cosicché un tele
di 500 mm è lungo quasi mezzo metro, mentre un 1000 mm può arrivare ad un metro.
Gli obiettivi catadiottrici invece, grazie ad un particolare schema
ottico che utilizza un paio di specchi, sono considerevolmente più corti
della loro effettiva lunghezza focale. |
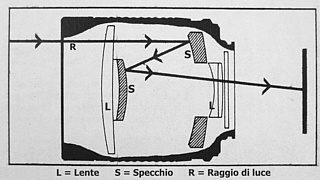 |
|
Schema ottico
di un obiettivo catadiottrico |
|
Un catadiottrico 500 mm, a differenza
di un teleobiettivo classico, può essere lungo solo una ventina di
centimetri e pesa molto di meno (fattore non trascurabile).
Questo è possibile perché, mentre negli obiettivi tradizionali i raggi
luminosi percorrono un tragitto rettilineo, nei catadiottrici vengono
riflessi due volte prima di arrivare sul sensore.
Questi tipi di obiettivi, molto pratici e leggeri, hanno però dei
problemi qualitativi legati allo schema ottico più o meno complesso,
agli specchi impiegati e al fatto che non possono utilizzare un diaframma. |
|
Chi li utilizza è costretto quindi a lavorare sempre a
tutta apertura e l'esposizione può essere controllata solo modificando
i tempi e/o utilizzando dei filtri grigi a densità neutra (ND). Inoltre le immagini
fuori fuoco, soprattutto i riflessi, assumono una tipica forma ad
anello che molti fotografi disdegnano quando non è utilizzata per fini artistici.
Il gruppo frontale può essere composto da una o più lenti ed ha lo
scopo di minimizzare gli effetti dell'aberrazione sferica introdotti dallo
specchio principale. L'elemento divergente che si trova lato sensore
ha invece lo scopo di eliminare la curvatura di campo, di distribuire
uniformemente la luce su tutta l'inquadratura e quindi di evitare fastidiosi
fenomeni di vignettatura. Tra le due zone speculari si trova una sorta di
paraluce interno che serve ad evitare interferenze tra i raggi di luce
riflessi dal 1° specchio (posto lato sensore) e dal 2° (posto nel gruppo
frontale).
In un catadiottrico la messa a fuoco avviene mediante un elicoide che
agisce variando la distanza tra i due specchi. |
 Gli obiettivi zoom
Gli obiettivi zoom |
Gli obiettivi zoom permettono la variazione della focale con lo
spostamento di un gruppo ottico interno. Hanno uno schema ottico molto più complesso
rispetto ad un obiettivo a focale fissa e, di conseguenza, peso e dimensioni possono essere
maggiori. Uno zoom può concentrare in una sola ottica il campo inquadrato da
un intero corredo di obiettivi.
Il primo zoom fotografico fu lo Zoomar 36-82mm f/2.8 della
Voitglaender a 14 lenti, che giunse sul mercato solo nel 1959, quasi
trent'anni dopo la nascita del primo zoom cinematografico. Prima degli anni
'80 del secolo scorso uno zoom solo grandangolare era solo un sogno. Ci
pensò la Sigma, grazie ad una tecnologia avanzata, a produrre un obiettivo
che conteneva la sua escursione entro le lunghezze focali della ripresa
grandangolare: dai 21 mm, con angolo di campo di 92° si passava ai massimi
35 mm, con angolo di campo di 63°. L'ottica si chiamava Sigma Wide Zoom
f/3,5 - 4 (21 - 35 mm) ed era facilmente regolabile nella messa a fuoco
e nella selezione focale grazie a due ghiere molto morbide.
Tutti i grossi problemi che hanno sempre ostacolato l'avvento degli zoom
nelle riprese fotografiche sono oggi brillantemente superati. Gli studi
effettuati grazie ai moderni sistemi tecnologici hanno permesso soprattutto
una migliore correzione delle distorsioni prospettiche e la limitazione
delle riflessioni interne - un tempo vera spina nel fianco - ottenuta con
particolari posizionamenti del diaframma.
Rimane il fatto che, proprio per la loro focale variabile, l'eliminazione
dei difetti sull'intero arco di utilizzo non è possibile. Quello che
adopero io, alla focale minima distorce a cuscinetto, sui 35mm è corretto,
alla focale massima presenta un'evidente distorsione a barilotto. Sempre
alla focale massima, le immagini perdono in nitidezza e contrasto. Nelle
foto notturne bisogna stare molto attenti alle riflessioni causate dalle
alte luci e quando si fotografa in controluce è preferibile usare sempre un
buon paraluce e controllare l'immagine nel mirino con il diaframma chiuso
sul valore impostato.
Una piccola dritta per utilizzare al meglio uno zoom è quello di
abituarsi a mettere a fuoco alla massima focale. Dettagli di
dimensioni maggiori e una ridotta profondità di campo ci permetteranno di
percepire più facilmente le differenze di fuoco tra un piano e l'altro
dell'immagine. Fatto questo si può scegliere la focale più adatta ad ogni
singola inquadratura e scattare la fotografia.
Spostare il comando delle focali di un obiettivo zoom durante un'esposizione
prolungata è uno dei sistemi migliori per dare la sensazione del movimento
in una scena statica o per aumentare l'impressione di velocità in un
soggetto dinamico. Il caratteristico effetto zoom delle linee che si
irradiano dal centro dell'immagine può essere variato in diversi modi e
perfezionato in base alle proprie esperienze.
La filosofia per l'utilizzo corretto di uno zoom è abbastanza
semplice: esso deve servirci a fare quell'aggiustamento minimo di
inquadratura che possa rendere migliore la nostra immagine, senza doversi
spostare troppo dal punto in cui ci troviamo. Questo comportamento è valido
anche quando alcuni fattori esterni possono ostacolare il nostro
avvicinamento al soggetto.
Ragionando in termini di passi, si può dire questo: finché lo zoom ci serve
per migliorare l'immagine evitandoci di fare due passi in qualunque
direzione, va bene, anzi benissimo; ma se lo zoom, nei nostri intendimenti,
deve servirci ad evitare di fare otto passi, allora va male. Va male nel
senso che spesso non è sbagliata la lunghezza focale dell'obiettivo che si
sta usando ma la posizione in cui ci si trova rispetto alla scena o al soggetto.
Lo zoom, dunque, non risolve una brutta inquadratura ma può rendere
eccellenti delle riprese che sono già buone in partenza. Chi pretende di più
può andare incontro a molte delusioni... |
 Gli obiettivi per la macrofotografia
Gli obiettivi per la macrofotografia |
La ripresa di
soggetti posti a pochi centimetri di distanza dalla lente anteriore è
demandata ai cosiddetti «macro», obiettivi nei quali i gruppi ottici che li
costituiscono sono studiati e trattati in maniera particolare e l'elicoide
di messa a fuoco ha un'escursione molto spinta. Escursione in grado di
allontanare le lenti dal piano focale in maniera notevolmente maggiore di
quanto accade con i normali obiettivi.
Possiamo trovare in commercio obiettivi macro di svariate lunghezze focali.
Anche molti zoom in commercio hanno la possibilità di effettuare riprese
«macro». Più la focale è lunga e più - a parità di rapporto d'ingrandimento
- si può lavorare lontani dal soggetto. E questo, soprattutto nella
fotografia naturalistica, è un vantaggio da non sottovalutare.
Un rapporto di riproduzione pari a 1:1 è equivalente alla riproduzione alla
grandezza naturale. Con una scala di 1:2, il soggetto viene riprodotto sul
sensore a metà della sua dimensione naturale. |
 Gli obiettivi autofocus
Gli obiettivi autofocus |
La quasi totalità degli obiettivi
comuni che vengono progettati per le reflex digitali è oggi dotata della
funzione autofocus. In tali obiettivi la ghiera di messa a fuoco è
collegata con un motorino elettrico i cui movimenti sono comandati direttamente dalla
fotocamera (quando questa è impostata su tale funzione) in base ai
rilevamenti effettuati da un modulo sensore. Quando un sistema AF autofocus
è attivato le opzioni di messa a fuoco selezionabili sono le più svariate.
Nelle reflex digitali l'autofocus è disinseribile: in questo caso la selezione del piano di
messa a fuoco deve avvenire girando manualmente la ghiera di messa a fuoco
posta sull'obiettivo.
Un sistema AF è comodo, pratico e veloce; in alcuni casi quasi
indispensabile, come quando si fotografano soggetti in movimento. Purtroppo
la rilevazione dei dati non è sempre perfetta e ci sono varie
situazioni nelle quali la messa a fuoco automatica può essere errata (vedi
glossario più sotto).
Gli errori più comuni di un sistema AF autofocus sono ammessi dagli stessi
produttori di apparecchiature fotografiche e vengono segnalati nei libretti
di istruzione delle fotocamere.
L'autofocus potrebbe non generare i risultati sperati con gli obiettivi
grandangolari e super-grandangolari soprattutto nel caso in cui il soggetto
risulti troppo piccolo in relazione all'area totale inquadrata oppure sia
confuso all'interno di una scena con tanti
particolari poco contrastati. |
 Per contenere i costi si può utilizzare un moltiplicatore di focale
Per contenere i costi si può utilizzare un moltiplicatore di focale |
I moltiplicatori di focale sono dei sistemi di lenti negative che fanno
divergere i raggi provenienti dall'obiettivo. Trattandosi di un sistema
ottico negativo non può essere usato da solo, cioè senza obiettivo in
quanto, in tal caso, non sarebbe in grado di produrre sul sensore
un'immagine a fuoco. Disposto invece dietro un normale obiettivo, qualunque
sia la sua focale, fa divergere i raggi di luce e li trasmette a fuoco su un
piano più distante. Ciò implica la necessità di aumentare il tiraggio, cosa
che viene soddisfatta dalla montatura stessa del moltiplicatore.
In pratica un moltiplicatore proietta l'immagine a fuoco su una superficie
più grande. Siccome il sensore non varia di formato, questa risulta
ingrandita solo nella parte centrale del soggetto. La cosa produce un
effetto simile a quello che si ottiene usando un obiettivo di focale più lunga.
I duplicatori e i triplicatori di focale trovano il loro migliore campo di
applicazione con i teleobiettivi in quanto, con costi molto contenuti e peso
inferiore, consentono di ottenere risultati simili ad un obiettivo
universale di media qualità.
Il rapporto d'ingrandimento mantiene invariata la minima distanza di messa a
fuoco e questo fa si che si possa fotografare un soggetto molto più piccolo
che non con il solo obiettivo, mantenendosi sempre alla stessa distanza.
I moltiplicatori di focale purtroppo generano un certo calo della qualità
dell'immagine, soprattutto nella nitidezza, e comportano una perdita di
luminosità dell'obiettivo che stiamo adoperando, dovuta al fatto che
l'immagine ingrandita viene distribuita su una superficie più ampia. In
alcune situazioni si avverte anche una leggera diminuzione del contrasto,
che comporta una minor saturazione e brillantezza dei colori.
Nei controluce, sulla qualità dell'immagine influiscono, oltre ai riflessi
interni caratteristici dell'obiettivo, anche quelli del duplicatore, che
possono portare ad una diffusione di luce molto evidente, con conseguente
impastamento di tutta la scena ripresa.
I moltiplicatori possono essere utilizzati anche in abbinamento con
obiettivi grandangolari, anche se la cosa ha poco senso. Invece che
duplicare un 28 mm, per esempio, è infatti preferibile utilizzare il normale
50 mm o lo zoom fornito in dotazione alla reflex come ottica base, perché i
livelli qualitativi sono decisamente migliori soprattutto per quanto
riguarda il contrasto, la definizione e la risolvenza. |
 Pulizia delle lenti di un obiettivo
Pulizia delle lenti di un obiettivo |
La polvere e lo sporco sono un
brutto cliente per gli obiettivi. Pertanto,
per una buona qualità delle immagini, è necessario
che le lenti siano sempre perfettamente pulite.
Bisogna fare comunque un distinguo tra lente
anteriore (o esterna) e lente posteriore (quella che
da sul corpo macchina). Le impurità sulla lente
anteriore non sono critiche: un poco di polvere o un
piccolo graffio non determinano uno scadimento
visibile dell'immagine. Invece una lente frontale con
molta polvere, un velo untuoso o qualche impronta
digitale da luogo ad un effetto «flou»
sulla fotografia, ovvero causa un peggioramento
della nitidezza. Questo perché i depositi di grasso e polvere sul cristallo
hanno l'effetto di diffondere le radiazioni luminose e produrre una
«morbidezza» generale dell'immagine. Nel fare un ritratto questa cosa
potrebbe tornare «artisticamente utile», cioè essere un pregio!
Anche eventuali filtri posti sulla lente frontale devono essere trattati con
la medesima cura dell'obiettivo.
La lente posteriore invece è critica e necessita di
massima pulizia. Niente polvere, niente impronte,
macchie o rigature (perché si vedrebbero), pena un
degrado sensibile della qualità delle fotografie.
Le lenti degli obiettivi vanno pulite con molta
delicatezza, usando delle apposite cartine ottiche.
Per eliminare eventuali macchie, o uno sporco più
deciso, i kit in commercio contengono un liquido apposito.
Quando si ripone la macchina fotografica nella borsa
o non si fotografa per lunghi periodi, è necessario
coprire la lente frontale dell'obiettivo con l'apposito tappo.
Anche il corpo dell'obiettivo va sempre tenuto ben
pulito. Un controllo maggiore va effettuato dopo che
si è fotografato in luoghi polverosi o su una
spiaggia, togliendo all'occorrenza salsedine e
sabbia con un pennello morbido per poi effettuare
una pulizia più accurata con un fazzoletto leggermente inumidito
con acqua dolce.
La qualità di un obiettivo decade anche se, per qualsiasi motivo, dovessero
depositarsi corpi estranei sulle lenti interne dell'ottica o
formarsi macchie di sporco. In questo caso una pulizia in proprio
sarebbe comunemente impossibile e si renderebbe necessario rivolgersi a
laboratori specializzati. Questo è un evento raro, soprattutto se
l'obiettivo viene usato o conservato con una normale cura. |
|
Glossario di
alcuni termini che vengono citati in questa pagina e che fanno riferimento ai modi di
utilizzo, alle tecniche di progettazione, alla costruzione e alla qualità degli
obiettivi che sono in commercio... |
 Angolo di campo
Angolo di campo |
|
E' l'ampiezza, espressa in gradi, del
campo inquadrato da un determinato obiettivo. Quanto maggiore e la
lunghezza focale di un obiettivo, tanto più stretto è il suo angolo
di campo, e viceversa. |
 Cerchio di confusione e iperfocale
Cerchio di confusione e iperfocale |
Il cerchio di confusione è fondamentale
per la nitidezza di una immagine, perché è la base della profondità
di campo. Nella fotografia ogni punto ubicato dinanzi o dietro
il piano del soggetto non viene riprodotto come un punto, ma come un
«cerchio di confusione». Tuttavia l'occhio umano accetta tutti i
cerchi di confusione come punti incisivi, finché essi non eccedono
il diametro di 0,1 mm quando visti da una distanza di visione
chiara, ovvero 25 cm.
Un'immagine full-frame 24x36 risulta nitida se il diametro del
cerchio di confusione non supera 1/1500 della lunghezza focale
dell'obiettivo normale, e cioè 1/30 di mm. Dal formato 6x6 in avanti
tale diametro può aumentare fino a 1/1000.
La distanza dalla macchina fotografica al di là della quale tutto
risulta nitido quando l'obiettivo è a fuoco sull'infinito viene
chiamata «iperfocale». Questa distanza dipende dalla lunghezza
focale dell'obiettivo e dall'apertura del diaframma. Se si mette a
fuoco l'obiettivo sull'iperfocale e si lascia immutato il diaframma
tutto risulta nitido da una distanza pari a metà dell'iperfocale
sino all'infinito. Questa combinazione di messa a fuoco e di
diaframma produce la massima profondità di campo per quell'obiettivo
e per quella apertura.
Per qualsiasi obiettivo, di qualsiasi focale e a qualsiasi apertura
di diaframma, l'iperfocale può essere calcolata con una semplice
formula matematica: si eleva al quadrato la focale (F) in millimetri
dell'obiettivo; il risultato così ottenuto ottenuto va diviso per il
prodotto che origina moltiplicando il numero corrispondente
all'apertura di diaframma (D) per il diametro del cerchio di
confusione (C) in millimetri, ovvero F²/DxC. |
 Contrasto
Contrasto |
Il contrasto è determinato dalla
differenza con la quale vengono riprodotte le aree fortemente
illuminate da quelle scure, ovvero in ombra. Nella fotografia in
bianco/nero un basso contrasto produce un'immagine con un numero
elevato di toni intermedi, tanto che non si riesce quasi ad ottenere
il bianco e il nero «puliti». Una foto invece è ad alto contrasto
quando è formata esclusivamente dal bianco e dal nero, senza toni intermedi.
Un basso contrasto determina una minore saturazione e brillantezza dei
colori, ovvero la foto risulta leggermente «slavata». Le fotocamere
digitali possono avere dei programmi appositi per riprodurre
correttamente scene piene di luce, con soggetti brillanti (High-Key),
oppure scene molto scure e cupe dove si renda necessario dare un
buon risalto ai particolari chiari e/o in
luce (Low-Key). |
 Diaframma e profondità di campo
Diaframma e profondità di campo |
I soggetti di quasi tutte le fotografie
hanno tre dimensioni: altezza, larghezza e «profondità». Ogni
obiettivo possiede una certa dose di «nitidezza in profondità».
Anche se noi mettiamo sempre a fuoco su un «piano» ben definito, gli
oggetti che si trovano davanti e dietro a questo piano, risultano,
entro certi limiti, nitidi. Questa zona nitida è tanto più profonda
quanto meno l'obiettivo è luminoso, quanto minore è la sua focale e
più distante il piano di messa a fuoco.
Questo si verifica perché tutti i punti che cadono davanti e dietro
il piano focale vengono riprodotti come dischi di diametro sempre
maggiore, in gergo ottico chiamati «cerchi di confusione» che, al di
sotto di una certa dimensione, l'occhio umano accetta come punti.
Nella maggior parte dei casi la suddetta «profondità inerente» non
basta a comprendere l'intera profondità del soggetto. Diventa così
necessario aumentare artificialmente la zona nitida facendo uso del
«diaframma».
Il diaframma consente di variare le dimensioni dell'apertura,
cioè la sezione attraverso la quale la luce entra in un sistema
ottico. L'apertura relativa di un obiettivo equivale alla sua più grande
apertura di diaframma. Questa apertura di diaframma indica la sua
massima luminosità.
Il diaframma è inserito nell'obiettivo stesso ed è
appunto come una «valvola» che consente il controllo
della luce che raggiunge il sensore. Man mano che si chiude, aumenta
la profondità di campo. Di contro, l'ottica diventa sempre meno
luminosa. La variazione avviene con numeri graduati (f/stop). Questi
numeri si ottengono dividendo la lunghezza focale dell'obiettivo per
il diametro delle rispettive aperture di diaframma. Queste sono
calcolate in modo che ognuna richieda un tempo di posa doppio di
quella immediatamente più larga (e cioè numericamente inferiore).
Per esempio: un'apertura di diaframma indicata dal numero 8 richiede
una posa doppia dell'apertura precedente, indicata dal numero 5,6.
Per controbilanciare l'oscuramento dell'immagine è necessario un
aumento del tempo di posa.
La chiusura del diaframma crea una zona nitida più profonda in
direzione della macchina fotografica ed in senso opposto, ovvero al
di là e al di qua del piano di messa a fuoco.
Il tipo più diffuso di diaframma è quello denominato a «iride»
perché realizzato con un sistema di lamelle incurvate, più o meno
numerose, scorrenti le une sulle altre e formanti un'apertura
circolare irregolare. |
 Difetti che si possono manifestare quando si usano obiettivi grandangolari
Difetti che si possono manifestare quando si usano obiettivi grandangolari |
I grandangolari sono obiettivi
«difficili» e quindi soggetti più degli altri a difetti e
aberrazioni. Di seguito alcuni inconvenienti che possono
manifestarsi in misura maggiore usando le corte focali:
● Aberrazione sferica:
comporta l'impossibilità di mettere a fuoco tutti i soggetti sullo
stesso piano e fa si che i punti vengano riprodotti come chiazze e
le linee rette come bande più o meno curve. Il fenomeno origina dal
fatto che quando un fascio di luce colpisce una lente i raggi
centrali sono poco deviati mentre quelli periferici, incidendo sulla
superficie ottica con un angolo maggiore, sono deviati in misura
maggiore. E' particolarmente evidente a tutta apertura e quindi può
essere ridotta diaframmando.
● Coma: fa somigliare i punti rotondi a delle forme a uovo, o
se si preferisce a delle stelle comete;
● Astigmatismo: é un
fenomeno di cui soffre anche l'occhio umano, che impedisce di
mettere a fuoco bene, in contemporanea, le linee verticali e quelle
orizzontali. In ottica si manifesta perché quando un fascio di luce
obliquo colpisce la superficie di una lente l'immagine formata non è
puntiforme ma bensì variabile tra un segmentino radiale ed uno
tangenziale, a seconda della posizione del piano focale. La migliore
posizione di fuoco si trova in una posizione intermedia tra i due
segmentini, che sono perpendicolari tra di loro.
● Curvatura di campo:
provoca un fenomeno simile a quello che si verifica durante la
proiezione delle diapositive. O si mette a fuoco al centro, oppure
ai bordi. Il difetto origina dal fatto che quando si riprende un
soggetto esteso, posto su un unico piano, i raggi obliqui non si
incontrano alla stessa distanza dalla lente in cui si incontrano i
raggi paralleli all'asse ottico.
● Distorsione: può
essere a cuscinetto oppure a barilotto quando l'immagine assume un
aspetto curvilineo simile a quello di una botte. E' un difetto
inaccettabile soprattutto quando l'obiettivo viene utilizzato per
le foto in ambienti urbani dove le linee cadenti dei palazzi devono
risultare perfettamente rettilinee, pena un effetto visivo veramente
sgradevole. Quindi, nell'acquisto di un grandangolo, la prima
cosa da controllare è che sia corretto sotto questo aspetto. La
distorsione non può essere ridotta diaframmando. Negli obiettivi
fotografici viene corretta con
l'adozione di schemi ottici simmetrici rispetto alla posizione del
diaframma.
● Aberrazione cromatica: crea problemi soprattutto nelle foto
a colori in quanto causa un alone iridescente attorno ad ogni
soggetto. E' un fenomeno tipico degli obiettivi con pochi elementi,
che si verifica in quanto l'indice di rifrazione di un vetro ottico
varia con il colore della luce incidente e quindi i raggi di diverso
colore che compongono la luce bianca emergono dall'obiettivo con
angoli diversi. In questo modo ogni colore ha un suo punto di fuoco.
Questo difetto si riduce diaframmando e viene compensato accoppiando
due lenti che portano i raggi luminosi blu e giallo sullo stesso
fuoco. |
 Esposizione
Esposizione |
|
E' la corretta quantità di luce che,
passando attraverso un obiettivo, giunge sul sensore per dare luogo
ad un'immagine prefissata. Una quantità di luce eccessiva
produce una «sovraesposizione» che rende le fotografie più
chiare del normale. Quando invece otteniamo un'immagine molto scura,
con dettagli non ben identificabili, siamo incorsi in una
«sottoesposizione», ovvero la luce in entrata è risultata
inferiore a quella che sarebbe stata necessaria. |
 Piano focale
Piano focale |
|
E' il piano sul quale un obiettivo mette
a fuoco un determinato soggetto. Per poter ottenere immagini nitide
è necessario che il piano focale coincida con la superficie del
sensore sulla quale viene fissata l'immagine. |
 Riflessi, rifrazione e dispersione
Riflessi, rifrazione e dispersione |
● Riflesso: in ottica è un effetto che
viene generato non soltanto da superfici opache, ma anche da mezzi
trasparenti. Un esempio è dato dalle lenti di vetro che riflettono
una parte di luce incidente su di esse. Senza tecniche avanzate di
coating, le perdite da riflesso non consentirebbero tecnicamente la
produzione di sistemi ottici complessi a molti elementi.
● Rifrazione: è il cambio di direzione di un
raggio di luce all'atto in cui esso passa da un mezzo trasparente in
un'altro di densità differente. La rifrazione si verifica perché la
velocità della luce varia con la densità del mezzo che attraversa.
L'azione degli obiettivi è basata sulla rifrazione.
● Dispersione:
le lenti degli obiettivi, pur sembrando perfettamente trasparenti,
assorbono sempre una parte della luce che le attraversa. Una
quantità anche maggiore si disperde col riflettersi della luce sulle
superfici delle diverse lenti che compongono l'obiettivo. Questo
effetto è proporzionale al numero delle lenti di cui un obiettivo è
composto. Nella maggior parte degli obiettivi in commercio la
perdita di luce è assolutamente trascurabile agli effetti del
calcolo del tempo di posa. |
 Situazioni più comuni nelle quali un sistema AF autofocus può non funzionare
correttamente
Situazioni più comuni nelle quali un sistema AF autofocus può non funzionare
correttamente |
|
Quando una fotocamera è impostata sulla
funzione AF autofocus la ghiera di essa a fuoco dell'obiettivo viene
attivata automaticamente. E' la macchina fotografica che, tramite un
sensore di rilevamento, decide il piano di messa a fuoco ottimale.
Come detto più sopra, questa opzione presenta delle criticità. Di
seguito un elenco delle situazioni più comuni nelle quali l'autofocus può
sbagliare, tenendo in conto (per esperienza sul campo), che vanno
tenuti d'occhio anche i colori dei
soggetti fotografati. Per esempio, il rosso e il verde possono
aumentare il margine di errore già insito nelle seguenti situazioni: |
● Soggetti lucidi e/o
brillanti e/o riflettenti:
Carrozzerie delle auto, specchi, vetri, cartelloni pubblicitari ecc.;
● Superficie acquee: mare, fiume, lago, piscina ecc.;
● Soggetti molto particolareggiati: esempio un campo pieno di fiori;
● Persone che indossano pellicce; animali dal folto pelo;
● Soggetti molto piccoli rispetto all'area totale inquadrata;
● Soggetti aeriformi come nuvole, fumo o fiamme;
● Soggetti che risaltano poco rispetto allo sfondo;
● Soggetti ripresi in un ambiente poco illuminato;
● Soggetti in rapidissimo movimento: ho già illustrato, in altre
schede tecniche, alcuni tipi di errore che a volte incidono nelle foto sportive. |
Alla luce di quanto sopra, si può riscontrare che è molto
problematico mettere a fuoco correttamente in automatismo un'autovettura con la
carrozzeria rossa, un gatto rossiccio dal folto pelo, il letto di un
fiume o un incendio...
In questi casi e in altri minori non presenti
nell'elenco (ma che possono risultare da esperienza diretta) la
certezza di mettere a fuoco in modo corretto si raggiunge solamente
disinserendo l'autofocus e regolando manualmente la ghiera di messa a
fuoco posta sull'obiettivo.
Come già segnalato in altre schede tecniche, gli oggetti luccicanti
e le superfici acquee hanno una forte luminosità e influenzano
notevolmente l'esposimetro. Quindi una
fotografia ottenuta in completo automatismo potrebbe risultare
sbagliata dal punto di vista del fuoco e dell'esposizione (più scura
del normale). |
 Stop
Stop |
|
E' la misura comparativa
dell'esposizione. Ogni scatto di variazione dell'apertura del
diaframma o della velocità di otturazione (esempio da f/2,8 a f/4,
oppure da 1/125 a 1/250) rappresenta uno stop e raddoppia o dimezza
la quantità di luce che raggiunge il sensore. |
|
|
Tolte
dal
Cassetto
- Finestre fotografiche su Liguria e Toscana
Copyright © 2001 - 2024 Giovanni Mencarini. Tutti i diritti riservati.
(All Rights Reserved) |
|
|
|
| |
|